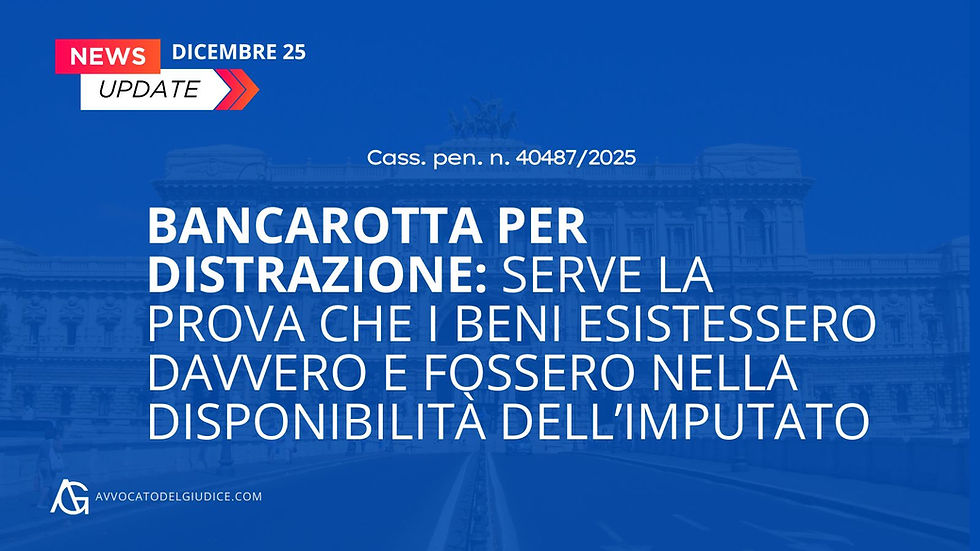Bancarotta e autoriciclaggio: due reati in concorso o in conflitto? (Cass. Pen. n. 13352/23)
- Avvocato Del Giudice

- 3 apr 2023
- Tempo di lettura: 11 min
Aggiornamento: 13 set 2025
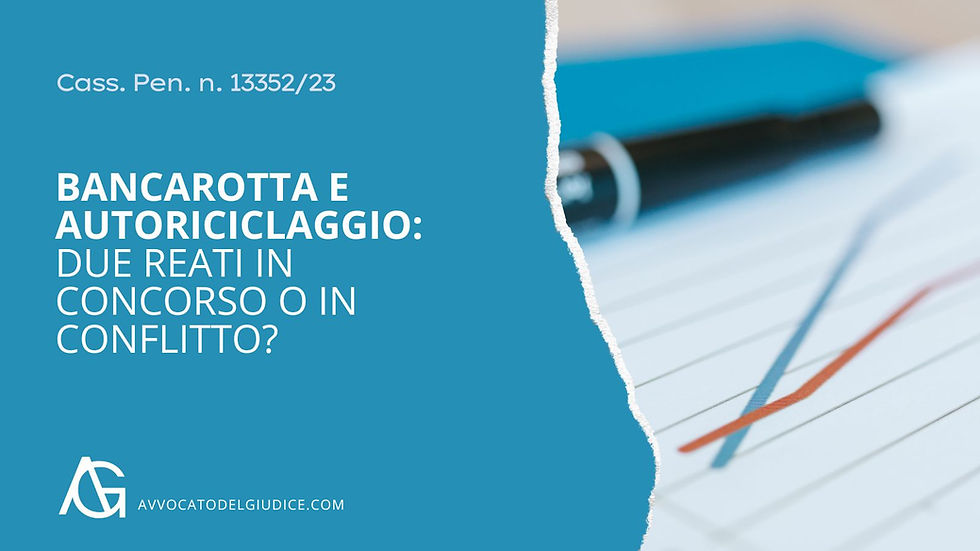
Indice:
1. Introduzione
1. Introduzione
La materia dei reati fallimentari ha conosciuto, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), un processo di trasposizione normativa che, pur nella novità codicistica, ha mantenuto una linea di continuità con la tradizione della legge fallimentare del 1942. In tale contesto, l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si concentra oggi sul rapporto tra il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 322 CCII) e la più recente incriminazione di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotta nel 2014 e caratterizzata da un impianto sanzionatorio di particolare rigore.
La questione centrale riguarda la possibilità – e i limiti – del concorso tra le due fattispecie, tema che si colloca all’incrocio tra diritto penale dell’economia, principi costituzionali (ne bis in idem sostanziale) e tutela del mercato legale.
2. La bancarotta fraudolenta distrattiva
L’art. 322 CCII ricalca l’impianto dell’abrogato art. 216 l. fall., punendo l’imprenditore in liquidazione giudiziale che “occulti, dissimuli, distragga, distrugga o dissipi, in tutto o in parte, i beni” aziendali, compromettendo la garanzia patrimoniale dei creditori.
Elemento cardine è la lesione della par condicio creditorum, attraverso una condotta che sottrae o devia il patrimonio sociale dalla sua destinazione vincolata. La giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che la distrazione può consistere tanto nella materiale sottrazione di un bene, quanto nel suo impiego per finalità estranee all’attività imprenditoriale.
È indifferente, ai fini della tipicità, che la condotta sia prefallimentare (posta in essere in costanza di impresa) o postfallimentare (successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale): ciò che rileva è il danno arrecato ai creditori.
3. L’autoriciclaggio come fattispecie autonoma
L’art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 186/2014, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chi, “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Il legislatore ha previsto una clausola di non punibilità per l’uso o il godimento meramente personale dei proventi illeciti, segnalando la ratio di incriminare non la mera fruizione, bensì l’inquinamento dell’economia legale mediante la reimmissione dei profitti in attività finanziarie, speculative o imprenditoriali.
Il reato, inoltre, è ricompreso tra le ipotesi presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-octies), estendendo così l’area di rischio anche alla persona giuridica.
4. Il problema del concorso: sovrapposizioni e limiti
La questione del concorso tra bancarotta distrattiva e autoriciclaggio si è posta con particolare intensità negli ultimi anni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente il mero trasferimento dei beni della fallita ad altra società gestita dal medesimo soggetto, poiché tale condotta coincide con la distrazione e non integra di per sé l’autoriciclaggio.
Occorre, piuttosto, un quid pluris: un’attività successiva e autonoma di reimpiego o trasferimento idonea ex ante ad ostacolare la tracciabilità del bene illecito. In altre parole, la linea di confine si colloca tra la semplice violazione della par condicio creditorum (tipica della bancarotta) e l’ulteriore lesione dell’ordine economico (tipica dell’autoriciclaggio).
5. L’elaborazione giurisprudenziale
La Corte di cassazione, Sez. II, 14 marzo 2023, n. 13352, ha ribadito che il concorso tra i due reati non può fondarsi sulla medesima condotta di distrazione, in quanto ciò violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Tuttavia, qualora dopo la distrazione si accerti un’attività di reimpiego – ad esempio attraverso intestazioni fittizie, costituzione di società “clone” o operazioni finanziarie dissimulatorie – si configura il concorso di reati.
Già in precedenza, la giurisprudenza aveva sottolineato che l’autoriciclaggio non si consuma con il versamento del profitto illecito su conti o carte intestate allo stesso autore del reato presupposto (Cass. pen., Sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074), poiché manca in tal caso la capacità dissimulatoria. Al contrario, si è ritenuta rilevante la condotta di reinvestimento in imprese terze o intestate a prestanome, idonea a rendere opaca l’origine del bene (Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2019, n. 16059).
6. Considerazioni conclusive
Il sistema appare oggi orientato a distinguere con nettezza tra:
la distrazione come lesione della garanzia patrimoniale dei creditori;
l’autoriciclaggio come attività ulteriore, connotata da un intento di dissimulazione e di reimmissione nel circuito legale, volta a ledere l’ordine economico.
La configurabilità del concorso, pertanto, dipende dall’accertamento di una condotta autonoma e successiva alla distrazione, dotata di idoneità dissimulatoria.
Tale approccio consente di evitare duplicazioni punitive, rispettando il principio di proporzionalità, ma al tempo stesso di reprimere più severamente le forme sofisticate di gestione post-fallimentare che, sfruttando meccanismi societari o finanziari, amplificano l’offesa al mercato legale e alla fiducia dei consociati.
7. La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 14/03/2023, (ud. 14/03/2023, dep. 30/03/2023), n.13352
RITENUTO IN FATTO
1.1 II tribunale della libertà di Roma, con ordinanza in data 24 ottobre 2022, rigettava l'appello avanzato dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari dello stesso tribunale che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 648 quater c.p. sino alla somma di Euro 218.606,50 nei confronti di C.C., indagato dei reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio.
Riteneva il tribunale che il trasferimento della predetta somma dalla (Omissis) s.r.l., poi dichiarata fallita, ad altre società del gruppo C. non integrasse l'ipotesi di cui all'art. 648 ter1 c.p. in assenza di ulteriori attività decettive rispetto alla condotta distrattiva già integrante il reato presupposto di bancarotta sicché, il provvedimento cautelare reale, non andasse disposto.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma deducendo violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio che doveva individuarsi proprio nel denaro ripulito attraverso le operazioni di investimento nelle società diverse dalla fallita. e nella ricchezza illecitamente conseguita pari all'importo complessivo di Euro 218.606,50.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 (dep. 27/05/2020) Rv. 279407 - 02); in motivazione detta pronuncia precisa che:" deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità decettiva; una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 terl c.p. a qualsiasi fatto accertato. Proprio in applicazione dei sopra indicati principi deve essere escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili, l'emissione di fatture da parte delle diverse società e l'identificazione delle transazioni tra società, comporti automaticamente l'esclusione della punibilità della condotta ex art. 648 terl c.p.....Il criterio da seguire è pertanto quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Se si collegano infatti strettamente e direttamente i tre verbi con i quali esordisce il comma 1 dell'art. 648-ter.1. c.p. alle voci che descrivono la ‘destinazionì dei beni, è facile avvedersi che l'ubi consistam della norma è rappresentato dalla reimmissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità). L'idea di fondo, che sembra giustificare l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa infatti sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". La ratio dell'autoriciclaggio è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale. Il Giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.....Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione del bene nel circuito economico....". Ne consegue affermarsi che alla luce del predetto principio il trasferimento del profitto o prodotto del reato presupposto con mutamento della titolarità soggettiva tramite operazioni di reinvestimento in attività economiche o finanziarie integra un'ipotesi di autoriciclaggio punibile.
Quanto al tema che costituisce il punto decisivo dei due provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, costituito dalla impossibilità di identificare l'autoriciclaggio nella stessa condotta integrante il delitto presupposto la stessa sentenza citata (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 cit.) afferma espressamente che:" la capacità dissimulatoria debba essere individuata in condotte non ricollegabili al puro e semplice trasferimento di somme ed altresì come il fatto di autoriciclaggio abbia natura autonoma e successiva rispetto alla consumazione del delitto presupposto così che le due fattispecie non possano essere ravvisate a fronte di un'unica contestuale azione. Tale impostazione, certamente condivisibile, va ulteriormente approfondita e sulla base delle successive considerazioni va affrontata la problematica avanzata con il secondo motivo di doglianza; il presupposto da cui partire è la considerazione secondo cui ove attraverso il trasferimento ad altre imprese si attui il reinvestimento successivo dei profitti illeciti in attività economiche, finanziarie o speculative è aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648 terl c.p. che è costituito dall'ordine pubblico economico poiché appare davvero evidente che a cagione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative il mercato viene a subire l'effetto inquinante del reinvestimento del profitto illecito. E deve anche ritenersi che se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'intestazione del profitto illecito ad un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o capitali, vi è la possibilità di identificare una condotta dissimulatoria proprio perché mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Al proposito, occorre ricordare come questa stessa sezione della corte di cassazione ha affermato (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459) che non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. In motivazione si precisa che tale soluzione vale nei casi in cui vi sia identità soggettiva tra autore del delitto presupposto e soggetto titolare del medesimo bene a seguito della condotta di sostituzione; ove cioè autore del delitto presupposto e titolare del bene poi movimentato coincidano può affermarsi non esservi condotta concretamente idonea ad occultare l'origine illecita del bene. Ove invece la titolarità del bene anche attraverso successivi contratti sia mutata tale interpretazione non può trovare applicazione; difatti, la modifica della formale intestazione comporta condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l'origine illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile. Richiamando la già citata pronuncia della Sezione quinta (n. 8851 del 01/02/2019 cit.), va però ribadito che tale attività di trasferimento ad altro soggetto giuridico deve seguire, deve cioè essere successiva la consumazione del delitto presupposto produttivo di profitto illecito; al proposito altro precedente di questa Corte in tema di contratti di affitto di azienda poi dichiarata fallita ritenuti integrare un'ipotesi di bancarotta (Sez. 2 n. 38838 del 04/07/2019, Rv. 277098) afferma in motivazione che:" ai fini di evitare la doppia punibilità della medesima condotta infatti il legislatore con la introduzione della fattispecie di cui all'art. 648ter 1 c.p. ha chiesto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettive peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie. La sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio e quindi l'atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio". Deve pertanto essere escluso che possano configurarsi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto e ciò perché al proposito la dizione normativa è assolutamente chiara nel volere impedire categoricamente la violazione del principio del divieto di ne bis in idem sostanziale; difatti l'art. 648 ter 1 c.p. punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere...." un delitto presupposto operi poi attività di reimpiego e, quindi, l'utilizzo del termine verbale al passato chiarisce inequivocabilmente la necessità che la condotta di autoriciclaggio sia un seguito, un posterius della condotta tipica del reato presupposto.
Sulla base di tali postulati deve procedersi alla soluzione del caso in esame affermandosi che ove l'autoriciclaggio sia stato contestato in relazione alla sola condotta di distrazione delle somme dalla (Omissis) ad altre società vi è effettiva coincidenza delle due condotte con violazione del principio di doppia incriminazione; e cioè la omessa identificazione di condotte dissimulatorie successive la distrazione fornirebbe sostegno alla tesi sostenuta dai giudici di merito circa l'impossibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 648 terl c.p..
Ove però tale coincidenza non sussista poiché oggetto della contestazione ex art. 648 terl c.p. non è la sola attività distrattiva di somme dalla società fallita bensì, anche, le attività successivamente poste in essere con il denaro distratto dalle società beneficiarie dei pagamenti per cassa, il presupposto della coincidenza delle condotte affermato dai giudici di merito non appare sussistere sussistendo proprio un'ipotesi punibile di autoriciclaggio. Il carattere distintivo del concorso tra bancarotta ed autoriciclaggio va pertanto risolto anche alla luce dell'analisi dei beni giuridici tutelati e dell'effetto della condotta posta in essere sugli stessi; ove l'agente, con la distrazione di somme, abbia aggredito e leso solo la par condicio creditorum la condotta sarà punibile soltanto in forza delle norme dettate dalla legge fallimentare, ove invece alla condotta distrattiva sia seguita una successiva ed autonoma attività di reimpiego dei capitali in altre società comunque operanti nel settore economico e commerciale, l'aggressione e lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648ter1 c.p. costituito dall'ordine economico, determinerà il concorso punibile tra bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio. E ciò perché, evidentemente, la condotta distrattiva non si è limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita, allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, bensì ha determinato, successivamente ed autonomamente, l'operatività di attività economiche societarie. attraverso il reimpiego dei profitti illeciti e.quindi proprio quell'inquinamento delle attività legali che l'autoriciclaggio mira a colpire.
Sulla base delle predette considerazioni deve pertanto risolversi il caso in esame; orbene dall'analisi dell'imputazione risulta che al capo r) la condotta di cui all'art. 648ter1 c.p. viene elevata a carico del C. non in relazione ai pagamenti per cassa effettuati "svuotando" il patrimonio di (Omissis) ma in relazione anche ad altre e successive attività descritte come:" impiegava e trasferiva nelle attività economiche e imprenditoriali esercitate da (Omissis) s.r.l. e (Omissis) s.r.l." la somma complessiva già citata di Euro 218.606,50. Così che il punto decisivo appare proprio quello di valutare se, quantomeno a livello di fumus commissi delicti, il pubblico ministero abbia fornito elementi concreti per affermare che dopo la distrazione ed il trasferimento ad altre compagini sociali seguì un impiego delle somme in dette società con conseguente integrazione della condotta contestata proprio al capo r) secondo i principi in precedenza esposti. Analisi che invece il tribunale della libertà non appare avere compiuto essendosi limitato a condividere le argomentazioni del G.I.P. circa la non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648ter1 c.p..
Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio dovendo il tribunale del riesame procedere ad una nuova analisi del materiale indiziario in atti al fine di valutare proprio tale eventuale circostanza che permetterebbe l'adozione del sequestro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023