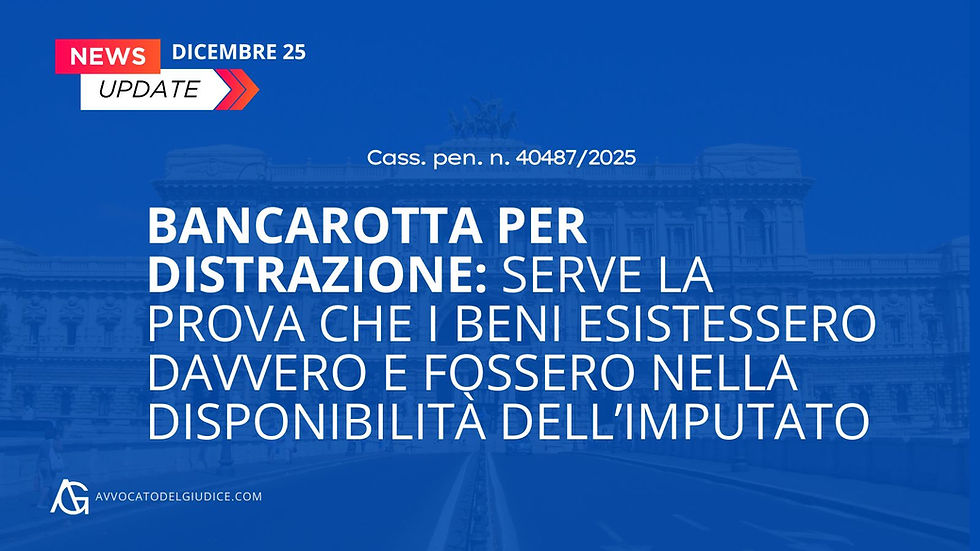Causazione dolosa del dissesto societario e operazioni dolose: la fisionomia della bancarotta impropria
- Avvocato Del Giudice

- 1 set 2025
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 2 set 2025
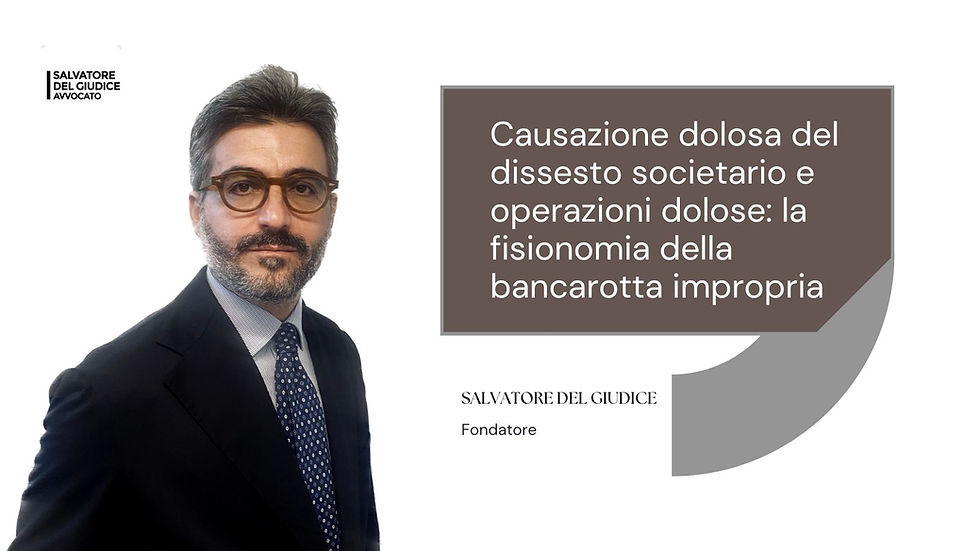
Indice:
1. La norma e la sua funzione di “clausola di chiusura”
L’art. 329, co. 2, lett. b CCI (già art. 223, co. 2, n. 2 l. fall.) punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società, applicando la pena prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Si tratta di una fattispecie definita in dottrina come “residuale e di chiusura”: essa è funzionale a colmare gli spazi lasciati scoperti dalle ipotesi tipizzate di bancarotta fraudolenta, estendendo l’area della responsabilità penale a tutte quelle condotte gestorie che – pur non integrando le figure tradizionali di distrazione, dissipazione, occultamento o simili – abbiano comunque inciso causalmente sulla genesi del dissesto.
L’opzione legislativa appare segnata da una scelta di politica criminale marcatamente repressiva: laddove sarebbe impossibile tipizzare tutte le possibili forme di mala gestio fraudolenta, il legislatore adotta una formula volutamente elastica, che rimette alla giurisprudenza il compito di selezionare, caso per caso, i comportamenti illeciti.
Una scelta, però, che genera seri problemi di determinatezza e tensioni con il principio di legalità, data l’ampiezza semantica di espressioni come “operazioni dolose” o “cagionare con dolo il dissesto”.
2. L’oggetto materiale e l’evento tipico
L’evento è rappresentato dal dissesto (oggi termine codicistico, prima indicato come “fallimento”), da intendersi quale squilibrio irreversibile tra attivo e passivo, tale da determinare l’impossibilità per la società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
La scelta del legislatore del 2019, sostituendo “fallimento” con “dissesto”, ha generato un dibattito:
secondo parte della dottrina, si tratterebbe di una modifica meramente terminologica, dato che già la giurisprudenza interpretava il termine “fallimento” in senso sostanziale;
secondo altri, la sostituzione non è neutra: la declaratoria giudiziale di liquidazione giudiziale assume oggi il ruolo di condizione obiettiva di punibilità, mentre l’evento naturalistico è il dissesto. Da qui l’ipotesi di una abolitio criminis per le condotte consistenti nella mera simulazione dello stato di insolvenza, prive di un effettivo dissesto sostanziale.
L’efficacia causale della condotta va misurata con riferimento al dissesto storicamente individuato dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, attraverso un’analisi rigorosa che distingua tra cause antecedenti, concorrenti e sopravvenute.
La giurisprudenza ha chiarito che anche l’aggravamento del dissesto già in atto è sufficiente a integrare il reato, se ha contribuito in maniera apprezzabile ad anticipare l’irreversibilità della crisi (Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2025, n. 24692).
3. Le due ipotesi alternative: “con dolo” e “per effetto di operazioni dolose”
3.1. La causazione “con dolo”
La prima ipotesi incrimina chi cagiona il dissesto con dolo diretto, ossia prevedendo e volendo il fallimento della società come conseguenza della propria azione od omissione.
Qui il legislatore sembra evocare una condotta gestoria che non si limita a prevedere e tollerare la crisi, ma che la persegue come esito consapevolmente voluto della propria azione od omissione.
In altri termini, siamo al cospetto di quelle gestioni deliberatamente suicidarie, nelle quali l’evento dissestuale rientra a pieno titolo nel disegno dell’amministratore.
Si tratta di casi nei quali l’impresa è piegata a scopi fraudolenti che ne rendono inevitabile la rovina: società costituite unicamente per emettere fatture false, per aggirare sistematicamente i fornitori senza alcuna prospettiva di continuità, o per drenare risorse a beneficio di altre entità, lasciando la fallita come un involucro vuoto.
La dottrina (Pedrazzi) ha efficacemente descritto simili condotte come una “gestione deliberatamente suicida”, destinata non già a perseguire l’oggetto sociale, ma a trasformare l’impresa in un mero strumento di frode.
In questo senso, il dissesto non è un effetto collaterale, bensì l’esito necessario e perseguito di un progetto gestorio che, sin dall’inizio, disvela il suo carattere patologico.
La peculiarità di questa ipotesi rispetto alla bancarotta patrimoniale tipica è evidente.
Nelle ipotesi di distrazione o dissipazione (art. 322 CCI, già art. 216 l. fall.) la punibilità deriva dal compimento di un atto tipico che sottrae beni o simula passività; nella causazione “con dolo”, invece, non è necessario individuare il singolo atto distrattivo, giacché l’intera politica societaria può essere finalizzata a provocare l’insolvenza.
Ciò che rileva non è tanto la tecnica operativa, quanto l’intenzionalità dell’evento dissestuale come esito voluto della strategia imprenditoriale.
È chiaro che una simile impostazione solleva interrogativi delicati sul piano della tipicità.
Punire la “gestione suicidaria” significa affidare all’interprete il compito di discernere, tra scelte imprenditoriali azzardate e scelte fraudolente, quelle che segnano il confine tra la mala gestio civilisticamente rilevante e la condotta penalmente rilevante.
Il rischio di una criminalizzazione eccessiva dell’azzardo imprenditoriale è concreto.
Proprio per questo, la giurisprudenza tende a richiedere, per la configurazione dell’ipotesi in esame, un quid pluris rispetto alla mera imprudenza: il dissesto deve risultare programmato e voluto, non semplicemente previsto come rischio eventuale.
3.2. La causazione “per effetto di operazioni dolose”
La seconda ipotesi delineata dall’art. 329, co. 2, lett. b CCI – quella della causazione del dissesto “per effetto di operazioni dolose” – è, senza dubbio, la più insidiosa sul piano dogmatico.
L’espressione, volutamente generica, rimanda a una nozione che la dottrina e la giurisprudenza hanno faticato a definire, proprio perché l’“operazione” non si esaurisce in un singolo atto isolato, ma evoca un’iniziativa complessa, articolata, idonea a incidere in modo significativo sul patrimonio sociale.
La definizione rimasta classica è quella di Nuvolone, che descrive l’operazione dolosa come «qualsiasi atto o complesso di atti patrimoniali, compiuti con abuso dei poteri o violazione dei doveri, con l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o arrecare un danno alla società o ai creditori».
In questa formula si colgono i tratti essenziali: non si tratta di una mera imprudenza gestionale, magari censurabile sul piano civilistico, ma di un comportamento intrinsecamente illecito, radicato nell’infedeltà ai doveri e nell’abuso della funzione.
L’elemento strutturale è, dunque, la complessità dell’operazione, che non coincide con la semplice distrazione o dissipazione di beni, bensì con una manovra più ampia, organizzata e spesso formalmente lecita.
Ciò che le conferisce rilevanza penale è proprio l’abuso dei poteri gestori, l’uso distorto della carica sociale per finalità contrarie all’interesse dell’impresa. In questo senso, l’attributo “dolose” non richiama il dolo di evento, così come definito dall’art. 43 c.p., ma segnala una vera e propria patologia dell’atto gestionale: l’atto è viziato alla radice perché animato da un intento infedele, volto a un profitto indebito o a un danno consapevole per la società e i suoi creditori.
Non a caso la Cassazione (sez. V, 5 dicembre 2014, n. 15613) ha ribadito che la qualifica “dolose” non deve essere letta in chiave strettamente penalistica, come sinonimo di volontà dell’evento dissestuale, ma come indice dell’illiceità intrinseca dell’operazione, anche laddove essa si presenti formalmente conforme al diritto. È la deviazione dagli obblighi di corretta amministrazione, la torsione della funzione gestoria rispetto ai fini dell’impresa, a rendere l’operazione dolosa in senso proprio.
In questa prospettiva, l’operazione dolosa si distingue tanto dalla semplice imprudenza (che può ricadere al più nella bancarotta semplice) quanto dalla distrazione classica: non è l’atto in sé, ma il programma gestionale infedele che conta, il quale, pur potendo apparire formalmente neutro, si rivela sostanzialmente pregiudizievole per il patrimonio e per le ragioni creditorie.
4. Il discrimine psicologico
Il nodo dogmatico centrale della bancarotta impropria da causazione del dissesto risiede nell’elemento soggettivo.
Le due espressioni utilizzate dal legislatore – “con dolo” e “per effetto di operazioni dolose” – non sono sinonimi, ma evocano atteggiamenti psicologici diversi dell’agente nei confronti dell’evento dissestuale.
Nel primo caso, quello della causazione “con dolo”, il dissesto costituisce un esito intenzionalmente perseguito.
L’amministratore lo prevede e lo vuole come conseguenza della propria condotta, orientando la gestione della società in modo tale da renderne inevitabile il tracollo.
È la figura della gestione deliberatamente suicidaria, in cui il fallimento non è un rischio collaterale ma il risultato programmato.
Qui il dolo assume la sua forma piena: volontà diretta dell’evento e consapevole sacrificio delle ragioni creditorie.
Diversa è la prospettiva delle “operazioni dolose”.
In questo scenario l’agente non mira direttamente al dissesto, ma compie atti intrinsecamente illeciti – per abuso dei poteri o infedeltà ai doveri gestori – accettando che da essi possa derivare la rovina dell’impresa.
L’evento fallimentare non è oggetto della volontà, ma è previsto e tollerato come conseguenza possibile.
La dottrina maggioritaria riconduce tale configurazione al dolo eventuale, ravvisabile ogniqualvolta l’amministratore, pur rappresentandosi il rischio del dissesto, decida di agire ugualmente.
Non manca, tuttavia, una diversa lettura che invita alla cautela.
Alcuni autori hanno infatti osservato che l’elasticità della formula legislativa rischia di sfociare in una forma di responsabilità oggettiva, con l’effetto di punire ex post qualsiasi operazione rivelatasi dannosa.
Per evitare questo esito, si propone di interpretare la norma secondo lo schema della preterintenzionalità in senso lato, richiedendo quantomeno la colpa in relazione all’evento.
In questa prospettiva, il dissesto dovrebbe risultare non soltanto prevedibile ma anche evitabile secondo un giudizio ex ante di diligenza, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988.
Resta, in ogni caso, fermo il discrimine con la bancarotta semplice impropria (art. 330 CCI): là dove la condotta è connotata da colpa – negligenza, imprudenza, inosservanza involontaria di obblighi – si ricade nella bancarotta semplice; quando invece vi è dolo, sia diretto che eventuale, si applica la più grave figura di cui all’art. 329, co. 2, lett. b.
5. La casistica giurisprudenziale
La lettura dell’art. 329, co. 2, lett. b CCI (già art. 223, co. 2, n. 2 l. fall.) è stata progressivamente affinata dalla giurisprudenza, che ha avuto il compito di riempire di contenuto una formula normativa intrinsecamente elastica. È proprio l’analisi dei casi concreti che consente di cogliere come la Corte di cassazione abbia cercato di individuare un criterio selettivo in grado di distinguere le condotte penalmente rilevanti da quelle ascrivibili a mera imprudenza o a responsabilità di tipo civilistico.
5.1. L’inadempimento tributario come operazione dolosa
Un primo filone, di particolare rilievo sistematico, riguarda l’omesso versamento sistematico delle imposte.
La Cassazione, sez. V, 17 giugno 2025, n. 24692, ha riconosciuto che la persistente inadempienza fiscale integra a pieno titolo un’“operazione dolosa”, idonea non solo a determinare ma anche ad aggravare il dissesto.
La Corte ha sottolineato che né la preesistenza di una situazione deficitaria, né la natura meramente “aggravante” della condotta interrompono il nesso di causalità con l’evento dissestuale.
La ratio di questa impostazione è chiara: il mancato versamento dell’IVA o delle ritenute non rappresenta una scelta imprudente, né un semplice ritardo, bensì una strategia gestionale consapevole che sottrae risorse alla massa dei creditori, favorendo un’illusoria prosecuzione dell’attività.
In questa prospettiva, l’inadempimento tributario non si esaurisce in una violazione di legge, ma si configura come un vero e proprio abuso del potere gestorio, poiché l’amministratore, nel deliberare di non adempiere agli obblighi erariali, persegue interessi estranei alla corretta gestione dell’impresa.
5.2. Le operazioni antieconomiche
Accanto all’omissione tributaria, un altro fronte riguarda le operazioni intrinsecamente antieconomiche.
Con la sentenza Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2024, n. 27690, la Corte ha ritenuto rientrante nella categoria delle operazioni dolose la cessione di un immobile a prezzo palesemente sottostimato, accompagnata da ulteriori distrazioni patrimoniali.
Ciò che rileva, in questa prospettiva, non è tanto l’illiceità formale dell’atto, quanto la sua assenza di giustificazione economica in relazione all’interesse sociale. L’antieconomicità manifesta diviene così indice di quell’“intrinseca illiceità” che connota le operazioni dolose e le distingue dalle scelte imprenditoriali legittimamente rischiose.
5.3. Le operazioni speculative e ad alto rischio
Una terza linea giurisprudenziale si è sviluppata con riferimento alle operazioni finanziarie ad alto rischio.
La Cassazione, sez. V, 9 luglio 2024, n. 36041, ha considerato “operazioni dolose” i contratti di associazione in partecipazione e gli acquisti azionari o immobiliari privi di garanzie reali, evidenziando come tali condotte fossero caratterizzate da un elevato grado di pericolosità per la società e da un’assenza di reale interesse gestionale.
La Corte ha respinto l’ipotesi di ricondurre simili comportamenti nell’alveo della bancarotta semplice impropria (art. 330 CCI), chiarendo che la prevedibilità ex ante dell’esito dissestuale basta a integrare il dolo.
In altri termini, quando la scelta gestionale è talmente avventata da rendere il dissesto non solo possibile ma altamente probabile, non si tratta più di imprudenza ma di condotta dolosa in senso penalistico.
5.4. Il concorso dell’extraneus
Infine, un ampliamento significativo della fattispecie si è avuto con la Cassazione, sez. V, 1 marzo 2024, n. 21854, che ha configurato il concorso in bancarotta impropria anche a carico di soggetti estranei al ceto gestorio.
Nel caso di specie, un esperto estimatore aveva dolosamente sovrastimato il valore di un bene conferito in capitale, concorrendo così a realizzare un progetto fraudolento degli amministratori e a ridurre le garanzie per i creditori.
La pronuncia segna un passaggio importante: l’“operazione dolosa” non è esclusiva degli amministratori, ma può coinvolgere anche professionisti o consulenti che, consapevolmente, contribuiscano alla sua realizzazione, ampliando il perimetro della responsabilità penale.
6. Considerazioni conclusive
La bancarotta impropria da causazione del dissesto rimane, ancora oggi, una delle fattispecie più controverse del diritto penale dell’economia.
La sua collocazione come “norma di chiusura” rivela tanto la volontà legislativa di presidiare gli spazi lasciati scoperti dalle figure tipizzate di bancarotta quanto la difficoltà di conciliare, in un settore ad alto tasso di rischio imprenditoriale, l’esigenza repressiva con il principio di determinatezza.
Non è un caso che le più recenti pronunce di legittimità abbiano esteso l’orizzonte applicativo fino a ricomprendere comportamenti eterogenei: dall’omesso versamento sistematico delle imposte (oggi espressamente ricondotto alla categoria delle operazioni dolose), alle cessioni sottocosto prive di logica economica, fino alle manovre speculative o alle sovrastime dolose operate da professionisti esterni.
La comune matrice non va cercata nel tipo di atto compiuto, ma nell’infedeltà gestionale che tradisce la funzione dell’amministratore come garante del patrimonio sociale.
È proprio su questo piano che si gioca la sfida interpretativa: trasformare una formula legislativa ambigua – ereditata da un linguaggio ottocentesco ormai distante dalla moderna dogmatica penalistica – in una disposizione conforme ai principi costituzionali.
Ciò implica, in chiave sistematica, tre corollari imprescindibili:i) circoscrivere l’ambito oggettivo ai soli atti contraddistinti da abuso o sviamento della funzione, escludendo le mere scelte imprenditoriali azzardate;
ii) richiedere, sul piano soggettivo, il dolo nelle sue forme piene o eventuali, rigettando ogni scivolamento verso modelli di responsabilità oggettiva;
iii) pretendere, sul versante causale, un nesso eziologico concreto e non ipotetico, idoneo a giustificare l’imputazione dell’evento dissestuale.
In mancanza di tali cautele, la norma rischia di trasformarsi in un contenitore onnicomprensivo, capace di attrarre ex post qualsiasi scelta gestionale rivelatasi esiziale, col risultato di appiattire la distinzione tra colpa e dolo e di incrinare il principio di colpevolezza.
Se invece letta come strumento di repressione dell’abuso consapevole della funzione gestoria, la fattispecie conserva un suo spazio coerente nel sistema, fungendo da presidio delle ragioni creditorie senza tradursi in una criminalizzazione dell’errore imprenditoriale.