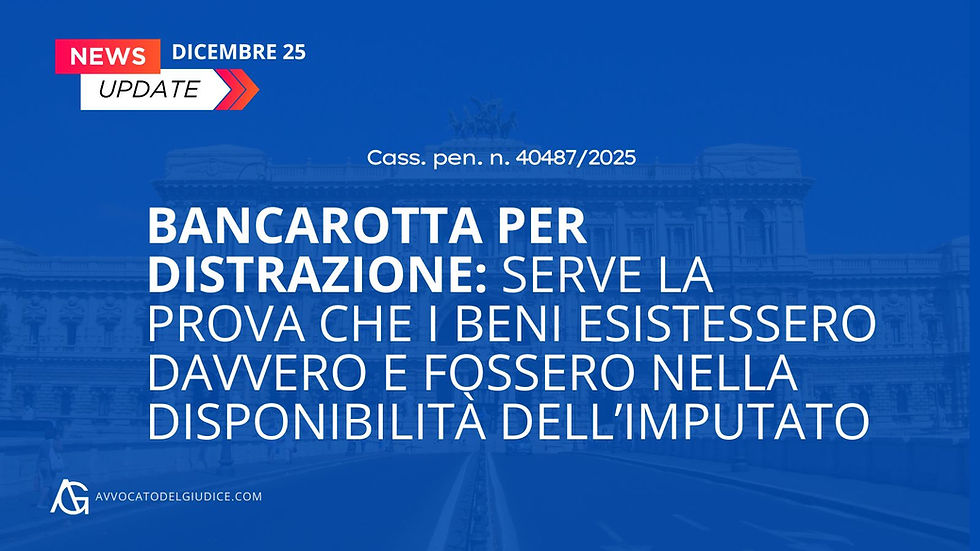Bancarotta semplice: il confine tra imprudenza gestionale e responsabilità penale
- Avvocato Del Giudice

- 31 ago 2025
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 2 set 2025

1. Premessa
La bancarotta semplice (art. 323 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — CCII, già art. 217 l. fall.) è la figura “di chiusura” del sistema penal-fallimentare.
Residuale rispetto alla bancarotta fraudolenta (“fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente”), essa convoglia condotte eterogenee accomunate dall’assenza di fraudolenza ma connotate da negligenza grave o imprudenza qualificata nella gestione dell’impresa in crisi.
Il suo baricentro è duplice:
funzione selettiva dell’intervento punitivo oltre la mala gestio meramente civilistica;
protezione dell’affidamento dei creditori al corretto governo dell’impresa, in coerenza con la garanzia patrimoniale ex artt. 2740–2741 c.c.
Su questo sfondo, l’analisi che segue tiene insieme testo normativo, dottrina (tra gli altri: Mazzacuva–Amati; Alessandri; Marini; Bricchetti–Pistorelli; Antolisei) e giurisprudenza di legittimità, con attenzione ai principi costituzionali di determinatezza e offensività.
2. Struttura della fattispecie
L’art. 323 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza delinea la fisionomia della bancarotta semplice, articolandola in tre grandi aree di incriminazione, ciascuna con una propria logica interna ma tutte accomunate dall’assenza di un intento fraudolento in senso stretto.
La prima area è quella della bancarotta semplice patrimoniale. Qui il legislatore ha raccolto una serie di condotte che, pur non traducendosi in una frode, denotano comunque una grave leggerezza nella gestione dell’impresa: dalle spese personali o familiari sproporzionate rispetto alla reale condizione economica, al consumo di una parte rilevante del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; dal compimento di atti di grave imprudenza diretti a ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale, fino all’aggravamento del dissesto derivante dall’omessa attivazione della procedura o da altre forme di colpa qualificata. Si tratta, in altre parole, di un ventaglio di comportamenti che non si presentano come dolosamente fraudolenti, ma che evidenziano una gestione sconsiderata, idonea a compromettere la garanzia dei creditori.
Accanto a questa, l’articolo contempla una seconda ipotesi: la bancarotta semplice da inadempimento, che riguarda l’imprenditore già beneficiario di un precedente concordato preventivo o liquidatorio e che non abbia rispettato le obbligazioni assunte. Qui la logica è diversa: non si punisce tanto una scelta imprudente di gestione, quanto piuttosto la violazione dell’affidamento riposto dai creditori e dall’ordinamento nel concordato, istituto che presuppone correttezza e lealtà nell’esecuzione.
Infine, il legislatore disciplina la bancarotta semplice documentale, che si realizza quando, nel triennio anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), l’imprenditore non abbia tenuto, o abbia tenuto in modo irregolare o incompleto, i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. In questo caso, non è in gioco tanto la dispersione del patrimonio, quanto la trasparenza: l’assenza o l’irregolarità della contabilità rende infatti difficile, se non impossibile, la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell’impresa.
Tutte queste ipotesi trovano un comune denominatore nella clausola di sussidiarietà con cui si apre l’articolo: la bancarotta semplice opera soltanto “fuori dai casi previsti” per la bancarotta fraudolenta. È dunque una figura residuale, che si muove in spazi lasciati liberi dalla più grave incriminazione fraudolenta. In tal modo, il legislatore delimita il perimetro applicativo ed evita sovrapposizioni punitive, preservando — almeno in astratto — il principio di tipicità.
3. Soggetti attivi e presupposto concorsuale
La bancarotta semplice è, in via principale, reato proprio dell’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale.
In ambito societario, l’area della responsabilità degli organi apicali è oggi disciplinata simmetricamente nel Capo II del Titolo IX (artt. 329–330 CCII), in continuità con gli artt. 223–224 l. fall., ma con tipizzazioni proprie.
In ogni caso, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale opera come condizione obiettiva di punibilità (Sez. Un., Passarelli, 31 marzo 2016, n. 22474): il fatto tipico si perfeziona ante procedura; la punibilità è subordinata al successivo avvio della procedura concorsuale, senza che occorra nesso causale o psicologico tra condotta e insolvenza.
4. Bancarotta semplice patrimoniale: criteri di tipizzazione e accertamento
La bancarotta semplice patrimoniale costituisce, all’interno dell’art. 323 CCII (già art. 217 l. fall.), il nucleo più complesso e al tempo stesso più problematico della figura in esame. Essa raccoglie condotte eterogenee, che spaziano dal consumo personale di risorse al compimento di operazioni imprenditoriali avventate, accomunate dall’assenza di un intento fraudolento in senso stretto ma segnate da una significativa deviazione rispetto ai canoni della corretta gestione. L’area di rischio penale si colloca, dunque, nello spazio liminale tra l’errore imprenditoriale tollerabile e la colpa grave idonea ad aggravare la decozione: un confine che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente tracciato, oscillando tra esigenze di selettività e tentazioni di criminalizzazione dell’insuccesso.
Un primo versante riguarda le spese personali o familiari sproporzionate. È la Cassazione, già con la sentenza 22 giugno 1971, n. 894, ad aver chiarito che la sproporzione va valutata ex ante, alla luce della condizione economica dell’imprenditore e dell’impresa al momento in cui l’esborso è compiuto. La giurisprudenza distingue tra spese razionali, seppur eccessive, che integrano la fattispecie semplice, e spese voluttuarie o del tutto irrazionali, che tendono verso l’area più grave della dissipazione fraudolenta. In prospettiva contemporanea, il parametro valutativo non può che essere quello dell’“imprenditore ragionevole”, oggi illuminato dai doveri di assetto organizzativo e di adeguata gestione codificati nell’art. 2086, comma 2, c.c.
Un secondo terreno applicativo riguarda le operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti. Nella prima categoria rientrano attività connotate dall’alea pura, come giochi o speculazioni slegate da logiche aziendali; nella seconda, operazioni d’impresa caratterizzate da un rischio macroscopicamente eccedente il normale, tanto da risultare riconoscibile ad occhio nudo. È la Cassazione (sez. V, 7 marzo 1989, n. 12874) ad aver sottolineato come la manifesta imprudenza si misuri sulla sproporzione oggettiva tra il rischio assunto e le capacità finanziarie e organizzative dell’impresa. La figura, generalmente letta in chiave colposa, si ancora alla prevedibilità ex ante dell’esito pregiudizievole, più che all’effettivo verificarsi del danno.
Di diverso tenore è la fattispecie delle operazioni di grave imprudenza compiute per ritardare l’apertura della procedura concorsuale. Qui il legislatore coglie una strategia di procrastinazione consapevole, e non il mero ottimismo gestionale.
La “gravità” dell’imprudenza, richiamata dal dato normativo, funge da filtro di tipicità, impedendo che ogni scelta imprenditoriale discutibile scivoli nell’area penale. La giurisprudenza ne ha offerto applicazioni emblematiche, ad esempio nella locazione dell’azienda in stato di decozione a controparti palesemente insolventi, per canoni incongrui, o in operazioni straordinarie prive di qualsiasi sostenibilità finanziaria (Cass., sez. V, 4 giugno 2003, n. 24231).
Non a caso, dottrina e giurisprudenza tendono a leggere questa figura in chiave dolosa, valorizzando la finalità consapevole di rinviare l’inevitabile dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Chiude il quadro la previsione sull’aggravamento del dissesto per mancata attivazione della procedura o per altra grave colpa. Si tratta di una condotta prevalentemente omissiva, che punisce l’imprenditore il quale, pur in presenza di insolvenza conclamata, ometta di sollecitare l’apertura della procedura, lasciando che la decozione si approfondisca.
Anche qui la valutazione è ex ante e si fonda sulla prevedibilità di un aggravamento dell’esposizione, coerente con la funzione di tutela anticipata che caratterizza i reati fallimentari.
Sul piano soggettivo, la dottrina prevalente colloca le ipotesi di spese eccessive, operazioni imprudenti e aggravamento del dissesto nell’orbita della colpa grave, intesa come deviazione dai canoni professionali e organizzativi dell’imprenditore diligente. Diversa la valutazione per le operazioni di grave imprudenza mirate a procrastinare la procedura, dove l’elemento soggettivo è stato qualificato in termini di dolo, in ragione della finalità specifica perseguita. È proprio in questa distinzione che si gioca la linea di confine tra l’errore gestionale non punitivo e la colpa penalmente rilevante: il legislatore non sanziona l’insuccesso economico in quanto tale, ma la condotta imprudente o negligente che, in presenza di decozione, assume un disvalore penale.
5. Bancarotta semplice da inadempimento (art. 323, comma 1, lett. e, CCII)
Una previsione peculiare, quasi un unicum nel panorama delle incriminazioni concorsuali, è quella della bancarotta semplice da inadempimento. La norma punisce l’imprenditore che non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
L’idea sottesa è quella del fallito recidivo: chi, dopo aver beneficiato di una procedura concorsuale minore, non ne rispetti gli impegni, si espone ad una presunzione di colpa particolarmente grave. Qui non è in gioco la sottrazione di beni né l’alterazione documentale, ma il venir meno alla lealtà verso i creditori e alla serietà degli accordi già omologati dal giudice.
La dottrina (Conti; Mazzacuva–Amati) ha sottolineato come questa ipotesi rifletta un giudizio di rimprovero che va oltre la dimensione economica: l’imprenditore inadempiente è visto come soggetto inaffidabile, che tradisce la funzione stessa del concordato.
Non a caso, si tratta di una figura autonoma rispetto alle altre bancarotte patrimoniali, in quanto qui non vi è un depauperamento dell’attivo, ma un comportamento che mina la fiducia nel sistema concorsuale.
Sul piano soggettivo, la questione è dibattuta. L’orientamento prevalente ritiene necessaria la prova del dolo, in quanto l’inadempimento volontario ad obbligazioni concordatarie non può ridursi ad una mera negligenza. Parte della dottrina, tuttavia, ha aperto alla possibilità di una colpa qualificata, evidenziando come la stessa nozione di inadempimento implichi comunque un giudizio di colpa. Resta, tuttavia, l’idea che il fulcro sia la volontarietà dell’inadempimento e non l’impossibilità oggettiva di adempiere.
6. Bancarotta semplice documentale (art. 323, comma 2, CCII)
La terza figura è quella della bancarotta semplice documentale, che punisce l’imprenditore che, nei tre anni antecedenti la liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’impresa se di minore durata), non abbia tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge, oppure li abbia tenuti in modo irregolare o incompleto.
Rispetto alla corrispondente ipotesi fraudolenta, qui l’oggetto della condotta è più ristretto: rilevano solo i libri e le scritture obbligatorie ex art. 2214 c.c., cioè il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture imposte dalla natura e dimensione dell’impresa. Sono quindi escluse le scritture facoltative, la contabilità parallela e quella “in nero”, che rientrano invece nel perimetro più ampio della bancarotta documentale fraudolenta.
La ratio è evidente: garantire la minima trasparenza contabile necessaria alla ricostruzione del patrimonio, senza pretendere un livello di completezza assoluta. Non a caso, la giurisprudenza (Cass., sez. V, 5 aprile 2019, n. 15061) ha chiarito che si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo presunto, che si consuma anche senza un danno concreto per i creditori: l’irregolarità contabile è di per sé lesiva perché ostacola il controllo sulla gestione.
Le condotte rilevanti sono tre:
la mancata tenuta delle scritture, cioè la totale assenza di documentazione;
la tenuta irregolare, consistente in difformità rispetto alle prescrizioni legali;
la tenuta incompleta, ossia la presenza di lacune tali da rendere difficoltosa la ricostruzione patrimoniale.
Anche qui il discrimine con la fattispecie fraudolenta non è solo quantitativo, ma soprattutto soggettivo: per la semplice è sufficiente la colpa (anche lieve, secondo alcuni), mentre per la fraudolenta è necessario il dolo. Si tratta dunque di una tipica ipotesi di responsabilità per negligenza gestionale, in cui il diritto penale interviene non a reprimere la frode, ma a sanzionare l’inosservanza dei doveri minimi di corretta amministrazione.
7. Regime sanzionatorio, aggravanti, pene accessorie
La cornice edittale è da sei mesi a due anni; la condanna importa inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi fino a due anni (art. 323, co. 3, CCII).
Operano, ove compatibili, le aggravanti di sistema (art. 326 CCII, già art. 219 l. fall.), tra cui la pluralità dei fatti e la rilevanza del danno.
Le pene accessorie rispondono alla ratio di prevenzione speciale, evitando ritorni rapidi a ruoli gestori dopo gravi deficit di diligenza.
8. Offensività, tipicità e standard probatori: una lettura costituzionalmente orientata
La riflessione sulla bancarotta semplice impone di interrogarsi sul suo spazio applicativo alla luce dei principi costituzionali di tipicità e offensività.
Tre, in particolare, sono i punti critici.
In primo luogo, la residualità della fattispecie non può essere intesa come un contenitore “onnivoro” nel quale far confluire qualunque condotta che non rientri espressamente nella bancarotta fraudolenta.
La clausola di sussidiarietà (“fuori dai casi preveduti”) non autorizza a colmare ogni lacuna con la semplice, ma va letta in senso restrittivo: essa individua un’area ricostruita “per difetto”, ossia limitata a comportamenti privi degli indici di frode che giustificano la risposta più severa.
In secondo luogo, la colpa deve funzionare come parametro selettivo e non come grimaldello per una responsabilità da risultato.
La giurisprudenza e la dottrina più avvertita richiamano il metro dell’imprenditore diligente, così come delineato dall’art. 2086 c.c. e dai doveri di assetto organizzativo. Non si tratta di giudicare ex post l’insuccesso dell’impresa, ma di verificare se, ex ante, la condotta presentasse un rischio prevedibile e ingiustificato di pregiudizio per la garanzia dei creditori.
Infine, occorre riflettere sulla natura di reato di pericolo che connota gran parte delle ipotesi di bancarotta semplice, specie in ambito documentale.
Anche in questo contesto, tuttavia, il giudizio di tipicità deve restare ancorato alla funzione di tutela: è necessario chiedersi se la condotta fosse effettivamente idonea a compromettere la ricostruzione patrimoniale o ad aggravare lo stato di dissesto. Solo così si può evitare che la fattispecie degeneri in una sorta di responsabilità da “status” del fallito, incompatibile con il principio di colpevolezza.
9. Conclusioni
La bancarotta semplice è lo spartiacque tra il rimprovero penale e la fisiologia del rischio d’impresa. Il suo buon governo dogmatico dipende da:
un uso parco e rigoroso della colpa, modulato sui doveri organizzativi;
una lettura non espansiva delle clausole elastiche (eccessività, imprudenza “grave”);
un controllo di offensività in concreto anche nei reati di pericolo, valorizzando il nesso funzionale con l’interesse dei creditori.
Solo così la figura conserverà la sua funzione di “cerniera” del sistema, senza trasformarsi in un diritto penale dell’insuccesso.
Fonti
N. Mazzacuva – E. Amati, Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, spec. 177–227.
A. Alessandri, Reati in materia economica, Torino, 2017, 327–376.
C. Marini, La bancarotta semplice (art. 217 l. fall.), in Reati in materia economica, Torino, 2017, 493–504.
R. Bricchetti – L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, Milano, 2017, 247–270.
F. Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale, passim.
G. Minicucci, Il dolo nella bancarotta. Alla ricerca della tipicità soggettiva della fattispecie patrimoniale, Firenze, 2018 (per la cornice generale su elemento soggettivo e offensività).