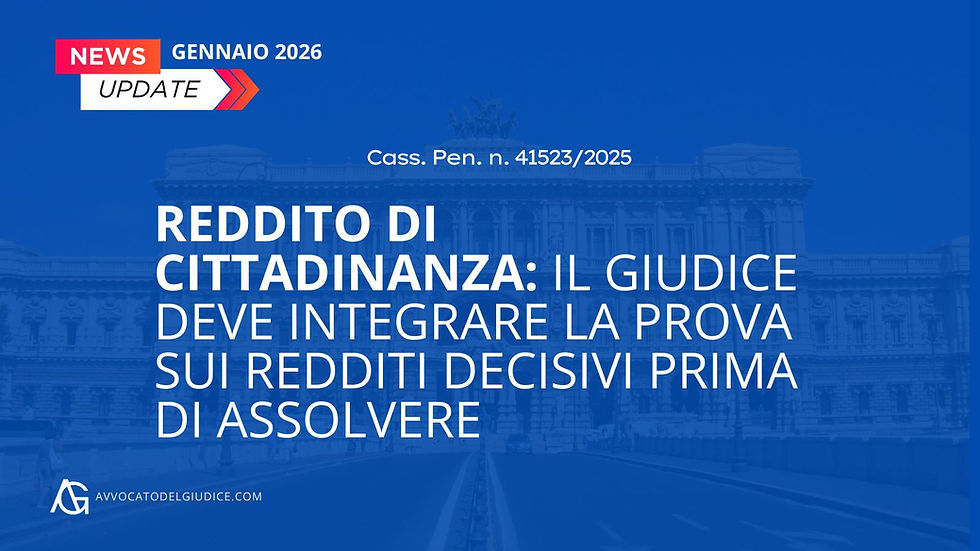Truffa assicurativa: il termine per proporre querela decorre dal momento della "piena cognizione" del fatto (Cass. Pen. n. 28369/25)
- Avvocato Del Giudice

- 16 ago 2025
- Tempo di lettura: 3 min

1. Premessa
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della vexata quaestio relativa alla decorrenza del termine per la proposizione della querela nei reati procedibili a istanza di parte, con specifico riferimento a una ipotesi di truffa assicurativa ex art. 642 c.p.
La sentenza assume rilievo non tanto per l’esito processuale (dichiarazione di inammissibilità del ricorso), quanto per il ribadito inquadramento del dies a quo del termine ex art. 124 c.p. e per l’ulteriore chiarimento in ordine all’onere probatorio gravante sulla parte che eccepisce la tardività.
2. I fatti di causa
Due imputati erano stati condannati per avere presentato ad Allianz S.p.A. una richiesta di risarcimento relativa a un sinistro mai avvenuto.
La compagnia, a seguito di indagini affidate a un’agenzia investigativa privata, aveva depositato querela.
La difesa deduceva la tardività dell’atto, sostenendo che il termine trimestrale fosse iniziato a decorrere già dal momento del rigetto della domanda risarcitoria (16 marzo 2018), e non dalla successiva relazione investigativa (3 maggio 2018).
La Corte di appello di Trieste aveva ritenuto tempestiva la querela, individuando il dies a quo nella data della relazione finale dell’investigatore, quando la compagnia ebbe contezza piena dell’illecito.
3. La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con una decisione che ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni già svolte dal giudice di merito. La Corte ha anzitutto chiarito che il termine di tre mesi per proporre querela decorre soltanto dal momento in cui la persona offesa raggiunge una piena cognizione del fatto di reato, e non già dalla mera percezione di irregolarità o anomalie.
Ha inoltre ricordato che l’onere di provare l’eventuale tardività grava su chi la eccepisce: in caso di incertezza, deve ritenersi valida la querela, in applicazione del principio di favor querelae.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione basata sull’art. 148 del Codice delle assicurazioni, in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, estranea all’oggetto del giudizio di appello.
4. Il quadro giurisprudenziale
La decisione del 2025 si inserisce in un percorso giurisprudenziale già tracciato. Già nel 2015 (Sez. 6, Saba, Rv. 266954) la Corte aveva chiarito che la “notizia del fatto” non coincide con un semplice sospetto, ma esige una conoscenza completa e certa degli elementi costitutivi del reato. Due anni più tardi (Sez. 2, Ippolito, Rv. 269726) era stato ammesso che, quando occorrano accertamenti ulteriori, la decorrenza possa legittimamente differirsi, purché si tratti di un tempo ragionevole e funzionale a colmare le lacune conoscitive. Nel 2014 (Sez. 5, Slimani, Rv. 263620) si era sottolineato che la decadenza dalla facoltà di querela va accertata con criteri rigorosi, senza indulgere a presunzioni o a ricostruzioni congetturali. Infine, le Sezioni Unite Zucchi (21 dicembre 2017, dep. 2018, Rv. 272170) avevano posto il principio di sistema: il termine trimestrale non può decorrere da una conoscenza frammentaria o meramente indiziaria, ma solo dal momento in cui la persona offesa dispone degli elementi indispensabili per un atto di querela consapevole e fondato.
La pronuncia in commento si muove dunque nel solco di questo orientamento, confermando che la “notizia del fatto” è una nozione qualificata e sostanziale, che non tollera riduzioni a mera percezione di anomalie, ma implica la piena cognizione del disvalore penale del comportamento.
5. Osservazioni critiche
La soluzione appare condivisibile. Il legislatore ha configurato la querela come atto a contenuto sostanziale (artt. 336 ss. c.p.p.), il che implica che essa non possa essere presentata sulla base di meri sospetti.
Tuttavia, l’enfasi sul “favor querelae” rischia di spostare l’equilibrio a danno delle garanzie difensive.
Il principio secondo cui “in caso di dubbio, la querela si presume tempestiva” può tradursi in una sostanziale compressione della certezza dei rapporti giuridici, lasciando l’imputato esposto a iniziative punitive anche dopo un lasso di tempo considerevole dal primo emergere delle anomalie.
In altri termini, l’interpretazione estensiva del dies a quo, pur giustificata dall’esigenza di tutelare l’offeso, finisce per collidere con la ratio dell’istituto della querela quale condizione di procedibilità soggetta a termine di decadenza breve.
6. Conclusioni
La Cassazione conferma un approdo giurisprudenziale ormai sedimentato: la decorrenza del termine di querela si aggancia alla piena cognizione del fatto di reato e non a conoscenze parziali o sospetti.
L’arresto si segnala, dunque, per la sua valenza di continuità con l’indirizzo delle Sezioni Unite, ribadendo che:
la tardività deve essere provata rigorosamente da chi la eccepisce;
l’inerzia colpevole della persona offesa non può tradursi in un’ingiustificata proroga;
in caso di incertezza, il diritto di querela prevale.
Resta aperta, tuttavia, la questione del bilanciamento con il diritto dell’imputato a non subire procedimenti oltre il termine di decadenza: una tensione destinata a riproporsi, soprattutto in materia di frodi assicurative, dove la linea di confine tra sospetto e cognizione piena resta inevitabilmente sottile.