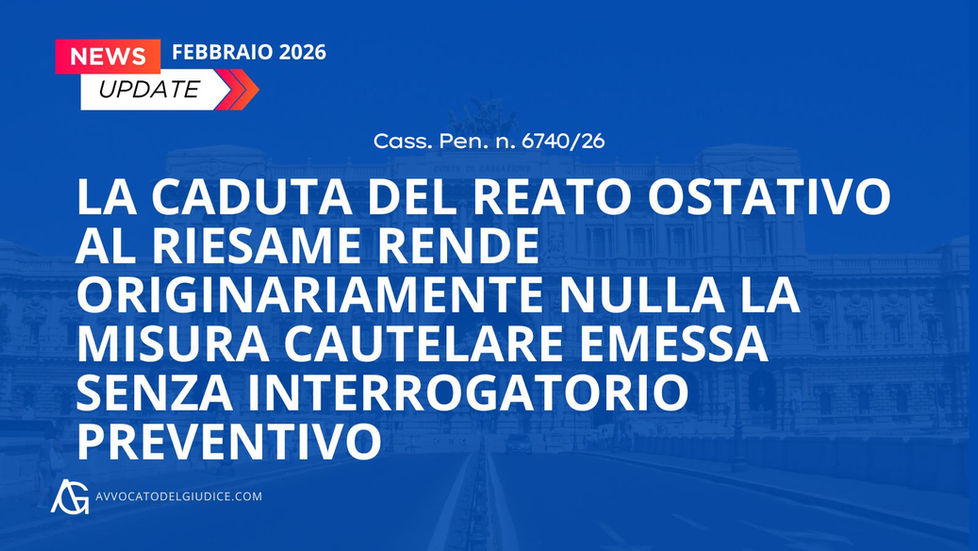Il reato di induzione indebita ex art. 319-quater c.p.: un tertium genus tra concussione e corruzione
- 13 set 2025
- Tempo di lettura: 25 min
Aggiornamento: 14 set 2025

Indice:
1. Origini e ratio della riforma del 2012
L’art. 319-quater c.p., rubricato Induzione indebita a dare o promettere utilità, costituisce uno snodo fondamentale nel sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
La disposizione è frutto della riforma recata dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (la cd. “legge Severino”), con cui il legislatore italiano ha inteso dare risposta tanto a pressioni di matrice sovranazionale quanto a esigenze interne di razionalizzazione del sistema repressivo della corruzione.
Come ricorda Trinci, fino al 2012, l’art. 317 c.p. disciplinava la concussione in termini unitari, ricomprendendo al suo interno sia le ipotesi di costrizione sia quelle di induzione.
Si trattava, come la dottrina osservava da tempo, di una fattispecie “anfibia”, incapace di distinguere con chiarezza la condotta del pubblico ufficiale che, mediante minaccia di un danno ingiusto, costringeva il privato, da quella in cui, attraverso un abuso meno invasivo ma comunque suggestivo o persuasivo, lo induceva a dare o promettere utilità indebite.
Questa commistione, come osserva Trinci, si rifletteva in una prassi applicativa non sempre lineare, che finiva per assorbire sotto la categoria unitaria della concussione comportamenti assai eterogenei, con conseguente difficoltà di tracciarne i confini rispetto alla corruzione.
Il punto di maggiore criticità era costituito dalla posizione del privato.
Nella tradizionale configurazione della concussione, questi era sempre qualificato come vittima, indipendentemente dal grado di libertà residua nella sua scelta di cedere alle pretese del pubblico ufficiale.
La dottrina segnalava l’incongruenza di un simile assetto: se il privato si determinava alla dazione non già per evitare un danno ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito, non poteva considerarsi mera vittima di concussione, bensì compartecipe di un meccanismo corruttivo.
La “vittimizzazione” indiscriminata dell’extraneus, infatti, lo deresponsabilizzava anche quando avesse tratto benefici personali dal rapporto illecito con il pubblico ufficiale.
A questa esigenza di distinzione si sommavano i rilievi provenienti da organismi internazionali. Il GRECO (Group of States against Corruption) e il Working Group on Bribery dell’OCSE avevano ripetutamente censurato il modello italiano, osservando che esso rischiava di consentire al privato di sfuggire alla punibilità, presentandosi come vittima concussa anche nei casi in cui avesse avuto un ruolo attivo nella vicenda criminosa.
Le preoccupazioni erano di natura non soltanto etica, ma anche pratica: la possibilità di presentarsi come vittima incentivava il privato a collaborare con gli inquirenti, ma al tempo stesso alimentava il pericolo di manipolazioni processuali, con la tendenza a qualificare condotte corruttive in termini di concussione per assicurarsi le dichiarazioni accusatorie dell’“indotto”.
In questo contesto maturò la scelta legislativa del 2012: scindere la concussione in due autonome figure, lasciando all’art. 317 la concussione per costrizione (riservata al pubblico ufficiale e punita più severamente, con la cornice edittale innalzata da 4 a 6 anni nel minimo), e creando il nuovo art. 319-quater per la concussione per induzione, ribattezzata induzione indebita a dare o promettere utilità.
La riforma non si limitò a spostare di collocazione la fattispecie induttiva, ma ne modificò radicalmente la fisionomia, prevedendo la punibilità anche del privato che ceda alla pressione indebita, sebbene con un trattamento sanzionatorio più mite.
In tal modo, il privato non è più considerato vittima tout court, bensì concorrente necessario: un soggetto che conserva un margine di autodeterminazione e che, pur indotto dal pubblico agente, decide di assecondarlo per trarre un vantaggio contra legem.
La ratio della riforma è dunque duplice: da un lato, ridimensionare l’area della concussione, confinandola ai soli casi di minaccia di un male ingiusto; dall’altro, responsabilizzare l’extraneus, chiamandolo a rispondere quando abbia approfittato dell’abuso per perseguire un proprio indebito arricchimento.
Non a caso la nuova fattispecie è stata collocata sistematicamente dopo i reati di corruzione e non più accanto alla concussione: un segnale chiaro del legislatore, volto a sottolineare l’affinità logica e strutturale dell’induzione indebita con la corruzione, più che con la concussione.
La norma si presenta, nelle parole di Trinci, come un reato-contratto, in cui le due parti partecipano a un illecito scambio, sebbene la spinta iniziale derivi dall’abuso del pubblico agente.
In conclusione, l’art. 319-quater rappresenta il tentativo del legislatore del 2012 di colmare una lacuna di sistema, rispondendo a sollecitazioni sovranazionali e a critiche dottrinali interne.
Esso si inserisce in un più ampio progetto di contrasto alla corruzione, che mira non solo a rafforzare le pene e le sanzioni accessorie, ma anche a ridefinire le categorie concettuali, tracciando una linea di confine più netta tra vittima e correo.
È su questo terreno che si innesta il dibattito successivo, dottrinale e giurisprudenziale, circa i rapporti tra induzione indebita, concussione e corruzione, e circa le zone grigie in cui le categorie tendono a sovrapporsi.
2. Testo normativo, struttura ed evoluzione legislativa
Il testo vigente dell’art. 319-quater c.p. recita:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»
La disposizione si articola in due commi:
il primo, che riguarda l’intraneus (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio);
il secondo, che punisce l’extraneus (privato).
Come sottolinea Trinci, la norma realizza un modello a concorso necessario, che responsabilizza entrambi i poli della relazione illecita, seppur con differente intensità sanzionatoria.
2.1 La disciplina del 2012
L’articolo fu introdotto dall’art. 1, comma 75, l. 190/2012. In quella versione originaria, la pena per il soggetto pubblico era fissata tra 3 e 8 anni di reclusione, mentre per il privato era prevista la reclusione fino a 3 anni.
Secondo Trinci, il legislatore recepì così il principio di continuità normativa rispetto al “vecchio” art. 317 c.p., scorporando dalla concussione la condotta induttiva ma, al contempo, creando un reato nuovo per il privato.
La ratio era chiara: non più deresponsabilizzazione dell’indotto, bensì riconoscimento della sua compartecipazione al disegno criminoso, sia pure con un trattamento sanzionatorio attenuato.
2.2 L’inasprimento del 2015
Con la l. 27 maggio 2015, n. 69, il legislatore è intervenuto esclusivamente sul trattamento sanzionatorio del primo comma, elevando il minimo edittale da 3 a 6 anni e il massimo da 8 a 10 anni e 6 mesi.
Come sottolinea Trinci, l’effetto non è solo simbolico: con la nuova cornice edittale, il delitto rientra stabilmente tra i reati di competenza del tribunale collegiale, per i quali è consentita l’applicazione della custodia cautelare in carcere, l’arresto in flagranza (facoltativo) e il fermo di indiziato di delitto. L’aumento edittale ha inciso altresì sulla prescrizione, sensibilmente allungata rispetto alla fase immediatamente successiva alla riforma del 2012.
2.3 La novella del 2020 e l’aggravante PIF
Un’ulteriore innovazione è giunta con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione (c.d. Direttiva PIF).Con l’inserimento della clausola finale nel secondo comma, è stata introdotta una circostanza aggravante ad effetto comune, che eleva il massimo della pena per il privato da 3 a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a € 100.000.
La norma, dunque, richiede la compresenza di due requisiti:
a) un nesso di lesione agli interessi finanziari dell’Unione;
b) una soglia quantitativa significativa del danno o del profitto.
Si tratta di un aggravamento di portata selettiva, espressamente modellato per armonizzare l’ordinamento italiano agli obblighi europei di tutela rafforzata delle risorse finanziarie comunitarie.
2.4 Diritto intertemporale e successione di leggi
La riforma del 2012 ha dato luogo a un fenomeno peculiare di successione di leggi: da un lato, continuità normativa rispetto al pubblico ufficiale, per il quale le condotte di induzione già punite ex art. 317 rientrano oggi nell’art. 319-quater; dall’altro, nuova incriminazione per il privato, che prima era considerato vittima e oggi diviene correo.
Ne discendono due corollari:
– al pubblico agente si applica il principio di retroattività della lex mitior (art. 2, co. 4 c.p.), con la possibilità di beneficiare del trattamento più favorevole;
– per l’extraneus, invece, opera il principio di irretroattività della legge penale (art. 2, co. 1 c.p.), sicché la sua responsabilità è limitata alle condotte successive all’entrata in vigore della norma.
Le Sezioni Unite (sent. n. 12228/2014, Maldera) hanno confermato questo assetto, riconoscendo che il passaggio da “vittima” a “soggetto attivo” del reato segna un’incriminazione nuova e non già un semplice mutamento di cornice sanzionatoria.
2.5 Collocazione sistematica
La sistematica collocazione dell’art. 319-quater, subito dopo i delitti di corruzione e non accanto alla concussione, è tutt’altro che casuale.
Secondo Trinci, essa riflette la volontà legislativa di qualificare la fattispecie non come species del genus concussione, bensì come figura più prossima alla logica corruttiva, in quanto contraddistinta da una logica negoziale (reato-contratto), benché innescata dall’abuso di qualità o poteri da parte dell’agente pubblico.
In questa prospettiva, la concussione per costrizione (art. 317) conserva natura pluri-offensiva, a tutela anche della libertà del privato, mentre l’induzione indebita è prevalentemente mono-offensiva, tutelando in via diretta il solo buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
3. Bene giuridico tutelato e natura del reato
L’individuazione del bene giuridico tutelato dall’art. 319-quater c.p. rappresenta una delle questioni più discusse a seguito della riforma del 2012.
Come osserva Trinci, la disposizione, collocata topograficamente nell’ambito dei delitti di corruzione, ma connotata da una dinamica di abuso della funzione pubblica tipica della concussione, si presta a interpretazioni non univoche.
3.1 Il bene giuridico primario: imparzialità e buon andamento della P.A.
Secondo l’orientamento prevalente, il delitto di induzione indebita tutela in via principale l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, principi scolpiti nell’art. 97 Cost. e assunti a parametro di legalità sostanziale dei pubblici poteri.
Il legislatore intende reprimere l’abuso della funzione pubblica quale strumento per mercanteggiare con il privato, piegando l’azione amministrativa a fini privatistici.
L’alterazione della funzione pubblica, ridotta a strumento di arricchimento illecito, costituisce il nucleo dell’offesa.
Da questa prospettiva, l’induzione indebita si colloca in linea di continuità con gli altri reati contro la P.A., perseguendo la salvaguardia dell’integrità dell’apparato amministrativo e della fiducia dei cittadini nella correttezza dei pubblici funzionari.
3.2 La posizione del privato: da vittima a correo
Il nodo problematico sorge rispetto al ruolo del privato.
Nella concussione ex art. 317 c.p., il privato è qualificato come vittima, la cui libertà di autodeterminazione è annullata o gravemente compressa dalla minaccia di un danno ingiusto.
Al contrario, nell’induzione indebita egli non solo non è vittima, ma è qualificato come soggetto attivo comune, destinatario di una sanzione penale (reclusione fino a tre anni, ovvero fino a quattro in presenza dell’aggravante PIF).
L’opzione legislativa si spiega con l’idea che, a differenza del concusso costretto, l’indotto conserva un margine di libertà decisionale: può scegliere di resistere alla pressione indebita, oppure di cedere, accettando la logica dello scambio corruttivo per conseguire un vantaggio personale.
In altri termini, il privato che aderisce alla richiesta del pubblico ufficiale non agisce più per certat de damno vitando (evitare un danno ingiusto), bensì per certat de lucro captando (cogliere un vantaggio indebito).
È questo spostamento di prospettiva a giustificare la sua punibilità.
3.3 Mono-offensività o pluri-offensività?
Il punto più delicato riguarda la qualificazione della natura offensiva della fattispecie.
Dottrina autorevole (Padovani, Gatta, Romano) e giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., n. 12228/2014, Maldera) affermano che l’induzione indebita è reato mono-offensivo, volto esclusivamente a proteggere l’interesse pubblico all’imparzialità amministrativa. Il privato non è soggetto passivo, ma correo, e dunque non riceve alcuna protezione dalla norma.
Altra parte della dottrina ha tentato di mantenere un profilo di tutela della libertà di autodeterminazione del privato, osservando che la pressione induttiva genera comunque una soggezione psicologica, che non può essere trascurata (tesi della pluri-offensività).
La previsione della punibilità dell’extraneus non escluderebbe, secondo questa lettura, la considerazione della sua posizione anche come vittima indiretta.
La prevalenza accordata dalle Sezioni Unite all’impostazione mono-offensiva sembra, però, aver segnato un punto fermo: il privato non è protetto dall’art. 319-quater, ma esclusivamente chiamato a rispondere quale compartecipe dell’offesa arrecata alla P.A.
3.4 La logica corruttiva della fattispecie
Collocando la norma accanto alle ipotesi di corruzione, il legislatore ha voluto rimarcare l’affinità dell’induzione indebita con il modello del reato-contratto.
Ciò che distingue l’induzione dalla corruzione vera e propria non è tanto l’oggetto della prestazione, quanto la dinamica relazionale:
– nella corruzione, le parti si muovono in un rapporto paritetico, negoziando lo scambio;
– nell’induzione, la trattativa nasce viziata dall’abuso della funzione pubblica, che condiziona la volontà del privato.
È dunque corretto affermare che l’induzione indebita rappresenta una figura “ibrida”: assimilata alla corruzione per struttura e collocazione, ma nata dallo scorporo della concussione e ancora segnata dalla logica dell’abuso.
3.5 Profili critici
L’opzione mono-offensiva, sebbene coerente con la ratio della riforma, non è priva di aporie.
Punire il privato significa considerarlo corresponsabile, ma non si può ignorare che egli agisce pur sempre sotto pressione psicologica, in una condizione di asimmetria relazionale con il pubblico agente.
Il rischio è di spingersi verso una concezione eccessivamente eticizzante, che pretende dal cittadino una resistenza quasi “eroica” alle indebite pressioni, pena la sua incriminazione.
È questo uno dei punti nevralgici del dibattito dottrinale: fino a che punto l’ordinamento può esigere dal privato di resistere all’abuso del pubblico ufficiale, e quando, invece, la pressione diviene tale da trasformarlo in vittima, spostando la fattispecie nell’orbita della concussione?
4. I soggetti
4.1 Il soggetto attivo pubblico
L’art. 319-quater c.p. configura, al primo comma, un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
La disposizione rispecchia – come osserva Trinci – la struttura della concussione (art. 317 c.p.), ma con una significativa differenza sistematica: l’inclusione degli incaricati di pubblico servizio anche nell’induzione indebita (mentre essi sono stati esclusi dall’art. 317 c.p. dopo la riforma del 2012).
Questa scelta legislativa trova la sua giustificazione nella natura stessa della condotta induttiva, che non implica necessariamente un potere autoritativo in senso stretto, ma può ben consistere in un atteggiamento persuasivo, suggestivo o allusivo, idoneo a sfruttare la posizione di preminenza riconosciuta anche agli incaricati di pubblico servizio.
La dottrina ha osservato come tale estensione sia “coerente con la ratio della norma, volta a colpire l’abuso della funzione pubblica in tutte le sue forme, non solo quelle fondate su poteri autoritativi” (Fiandaca–Musco, Parte speciale).
Va altresì ricordato che l’abuso può realizzarsi tanto nella forma commissiva (utilizzazione strumentale della funzione o dei poteri) quanto nella forma omissiva (mancato compimento di atti dovuti, purché idoneo a esercitare pressione sul privato).
La giurisprudenza ha confermato che anche il comportamento omissivo rientra nel paradigma dell’abuso: così, la Cassazione ha affermato che “l’abuso dei poteri può concretarsi nel mancato compimento di atti doverosi, se idoneo a indurre il privato alla dazione o promessa indebita” (Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2021, n. 10066).
4.2 L’extraneus: il soggetto attivo comune
Il secondo comma estende la punibilità al privato che dà o promette denaro o altra utilità. Qui la struttura è quella di un reato comune, che non richiede qualifiche soggettive.
Si tratta della novità più rilevante della riforma del 2012: il privato, da vittima della concussione per induzione, diventa correo necessario.
La sua punibilità non è simmetrica a quella del pubblico agente (poiché è prevista una pena assai più lieve), ma segna un vero mutamento di paradigma: da soggetto passivo a soggetto attivo.
Tale scelta è stata giustificata dal legislatore con la necessità di responsabilizzare il cittadino che, pur non costretto, accetta di entrare nel circuito dell’illecito, perseguendo un vantaggio contra legem.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “la punibilità del privato non esprime un’irrazionale duplicazione di responsabilità, ma si fonda sul margine di libertà decisionale che egli conserva, a differenza del concusso costretto” (Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, dep. 14 marzo 2014, n. 12228, Maldera).
4.3 Ipotesi particolari: il privato pubblico agente
La giurisprudenza ha affrontato casi peculiari in cui il destinatario della pressione induttiva sia, a sua volta, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. In tali ipotesi si pone il problema della maggiore “resistenza psicologica” che ci si aspetta da chi riveste funzioni pubbliche.
La Cassazione ha avvertito che la valutazione dell’effettiva soggezione deve essere particolarmente rigorosa, “in considerazione dell’elevato grado di resistenza che si esige da chi esercita funzioni pubbliche” (Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2015, n. 22526).
La qualificazione di costui come correo resta tuttavia ferma, qualora egli si determini comunque alla dazione o promessa indebita: la sua veste pubblicistica non lo rende immune dalla logica corruttiva insita nell’induzione.
4.4 Soggetto passivo
La fattispecie è stata unanimemente qualificata come reato a soggettività ristretta, in cui il soggetto passivo va individuato esclusivamente nella Pubblica Amministrazione.
Diversamente dalla concussione, non si può parlare di tutela anche della libertà di autodeterminazione del privato: questi, come detto, non è più protetto, bensì punito.
In tal senso, sottolinea Trinci, l’induzione indebita si configura come reato plurisoggettivo necessario: la sua struttura richiede la presenza di due soggetti (intraneus ed extraneus), entrambi penalmente rilevanti, ma con diversa intensità di responsabilità.
La P.A., invece, rappresenta l’unico vero soggetto passivo, in quanto titolare dell’interesse all’imparzialità e al buon andamento.
4.5 Terzi destinatari delle utilità
La norma prevede espressamente che la dazione o promessa possa essere destinata anche a un terzo.
La giurisprudenza ne ha dato una lettura ampia, ritenendo sufficiente che l’utilità sia destinata a una persona diversa dal pubblico agente, anche se legata da rapporti di parentela, amicizia o collaborazione.
Non rientra, invece, nel concetto di “terzo” l’ente pubblico presso il quale opera l’intraneus, in quanto il rapporto organico tra agente e amministrazione impedisce di configurarlo come beneficiario distinto: in tali ipotesi, la condotta può semmai integrare abuso d’ufficio o altre fattispecie affini (Cass. pen., Sez. VI, 23 luglio 2003, n. 31713).
5. L’elemento oggettivo: abuso e induzione
5.1 La struttura della condotta
Il nucleo materiale dell’art. 319-quater c.p. è duplice:
– da un lato, la condotta induttiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che deve necessariamente concretizzarsi in un abuso della qualità o dei poteri;
– dall’altro, la dazione o promessa indebita da parte del privato, che costituisce l’evento del reato.
Come osserva Trinci, la fattispecie si caratterizza, dunque, per una struttura causale complessa: occorre che l’abuso sia idoneo a provocare uno stato di soggezione psicologica nel privato, determinandolo a dare o promettere l’utilità.
Si configura, così, un doppio nesso causale: tra abuso e induzione, e tra induzione e dazione/promessa.
5. 2 L’abuso della qualità o dei poteri
Si parla di abuso della qualità quando il pubblico agente sfrutta il prestigio o l’autorevolezza della propria funzione per ottenere indebite utilità.
Diversamente, l’abuso dei poteri si ha quando il funzionario esercita in modo distorto e vessatorio le proprie attribuzioni.
La giurisprudenza ha chiarito che l’abuso può assumere anche la forma omissiva: il pubblico ufficiale si astiene dal compiere atti dovuti, sfruttando l’inadempimento come strumento di pressione.
Così Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2021, n. 10066, ha ritenuto integrata l’induzione indebita in caso di mancato rilascio di un atto dovuto, utilizzato come leva per ottenere una prestazione indebita.
Infine, rientra nel paradigma anche la condotta di chi prospetti poteri di ingerenza in settori formalmente non di sua competenza, ma pur sempre riferibili alla P.A. cui appartiene: Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 29321, ha ribadito che l’induzione indebita può sussistere anche quando il funzionario lasci intendere di poter influenzare decisioni di uffici diversi.
5.3 La condotta di induzione
La dottrina ha a lungo discusso il significato di “induzione”.
Tre le principali letture:
Tesi restrittiva: induzione come induzione in errore mediante inganno (Pagliaro).
Tesi dell’incompatibilità con l’errore: l’induzione non può coincidere con l’inganno, altrimenti si scivolerebbe nella truffa aggravata (Ravagnan).
Tesi ampia: induzione come qualsiasi comportamento idoneo a determinare uno stato di soggezione psicologica, anche attraverso persuasione, allusione o silenzio (Antolisei).
La giurisprudenza ha sposato la lettura estensiva: per la Cassazione, rientra nell’induzione “ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, anche velata o indiretta, purché sufficiente a influire sulla volontà del soggetto passivo” (Cass. pen., Sez. VI, 17 dicembre 2003, n. 49538).
In questo senso, l’induzione è concetto a forma libera, che si presta a ricomprendere condotte molteplici:– allusioni o richieste implicite;– silenzi ostinati;– ostruzionismi procedimentali;– persuasione subdola;– persino l’inganno, purché collegato all’abuso della qualità e non alla falsa rappresentazione della doverosità della prestazione (altrimenti si ricadrebbe nella truffa).
Come osserva Trinci, la differenza con la costrizione (art. 317 c.p.) non è quantitativa (grado di pressione), bensì qualitativa:– nella costrizione, il privato subisce una minaccia di danno ingiusto, che annulla la sua libertà di autodeterminazione;– nell’induzione, egli conserva un margine di scelta, ma viene convinto o condizionato a perseguire un indebito vantaggio.
Le Sezioni Unite Maldera (n. 12228/2014) hanno chiarito che il discrimine va ricercato nella dicotomia minaccia / non minaccia, e che nell’induzione indebita l’alterazione del processo volitivo non elimina, ma riduce e condiziona la libertà del privato.
5.4 L’evento
Come ricorda Trinci, consiste nel trasferimento materiale di un bene o utilità dalla sfera patrimoniale del privato a quella del pubblico agente o di un terzo. Può riguardare denaro, beni materiali, servizi, favori.
Basta anche una promessa credibile, non necessariamente formalizzata per iscritto.
È irrilevante che sia accompagnata da riserva mentale di non adempiere (Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 27723).
Ciò che conta è la sua idoneità oggettiva a consolidare il pactum sceleris.
Per “altra utilità” la giurisprudenza intende qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, purché concretamente apprezzabile: dal denaro ai beni materiali, dai favori sessuali (Cass. pen., S.U., n. 7/1993) fino al consenso politico o all’incremento di prestigio professionale (Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 7597).
La formula normativa “indebitamente” ha sollevato ampio dibattito.
– Secondo un filone, rappresenta una clausola di antigiuridicità espressa: esclude la rilevanza penale quando la dazione o promessa sia dovuta all’amministrazione per fini istituzionali.
– Secondo l’interpretazione prevalente, invece, l’indebito è insito nell’abuso: qualsiasi utilità ottenuta sfruttando la funzione pubblica è indebita, anche se fondata su un titolo privatistico del funzionario (Cass. pen., Sez. VI, 26 luglio 2011, n. 31341).
6. L’elemento soggettivo
6.1 La natura del dolo richiesto
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è sorretto dal dolo generico.
Sia per l’intraneus (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) sia per l’extraneus (privato), è sufficiente la rappresentazione e volontà degli elementi costitutivi del fatto.
Come ricorda Trinci, non occorre che l’agente persegua un fine ulteriore (ad esempio, arricchimento personale o vantaggio politico): basta la coscienza e volontà di abusare della propria funzione (per il soggetto pubblico) e di dare o promettere un’utilità indebita (per il soggetto privato).
La Cassazione ha più volte ribadito che “il dolo richiesto dall’art. 319-quater c.p. consiste nella consapevolezza dell’abusività della condotta e della indebitezza della prestazione, senza che rilevi il fine ulteriore perseguito” (Cass. pen., Sez. VI, 21 febbraio 2012, n. 8695; conf. Cass. pen., Sez. VI, 17 aprile 2013, n. 16154).
6.2 L’elemento psicologico dell’intraneus
Per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, il dolo deve comprendere:– la consapevolezza di rivestire una funzione pubblica e di abusarne;– la consapevolezza di influenzare il privato mediante un’induzione indebita;– la rappresentazione che il privato si determinerà a una dazione o promessa indebita.
La giurisprudenza ha chiarito che il dolo non richiede una volontà di coartare la libertà altrui (tipica della concussione), ma solo la coscienza dell’attività persuasiva o suggestiva idonea a piegare la volontà del privato.
È quindi sufficiente anche un atteggiamento apparentemente blando, purché percepito dall’agente come abusivo e orientato a ottenere un vantaggio non dovuto.
6.3 L’elemento psicologico dell’extraneus
Più complessa è la posizione del privato.
Punito come soggetto attivo comune, egli deve agire con coscienza e volontà di dare o promettere un’utilità indebita.
Ne discende che:– è esclusa la responsabilità se il privato ritiene in buona fede che la prestazione sia dovuta;– è invece configurabile il dolo se egli è consapevole del carattere abusivo della pretesa e cede pur di ottenere un vantaggio contra legem.
È proprio questa consapevolezza dell’indebito che distingue l’indotto dal truffato. Se il privato viene ingannato dal pubblico agente e ritiene di adempiere un obbligo legittimo, non vi è concorso nell’induzione indebita, ma semmai vittimizzazione in una truffa aggravata.
La Cassazione ha precisato che “il privato risponde ex art. 319-quater c.p. solo se è consapevole che la dazione o la promessa avviene in assenza di titolo legittimo e in conseguenza di una pressione indebita esercitata dall’intraneus” (Cass. pen., Sez. VI, 26 giugno 2012, n. 31341).
6.4 La questione della “resistenza dovuta”
Il legislatore, punendo il privato, ha implicitamente preteso da lui un dovere di resistenza alle indebite pressioni.
Qui si colloca una delle principali critiche dottrinali: non è sempre realistico esigere dal cittadino un comportamento “civicamente eroico” di rifiuto, specie in contesti segnati da radicate prassi corruttive o da rapporti asimmetrici con il potere pubblico.
Parte della dottrina (Spena) ha denunciato il rischio di “eticizzare” il diritto penale, trasformandolo in strumento di moralizzazione, piuttosto che di tutela di beni giuridici concreti.
Altri autori (Padovani) hanno invece difeso la scelta legislativa, ritenendo che punire l’indotto sia l’unico modo per disincentivare la logica del mercimonio e spezzare il circuito corruttivo.
6.5 Profili di dolo eventuale e colpa
Alcuni casi di confine hanno sollevato dubbi sulla possibilità di configurare un dolo eventuale: ad esempio, quando il privato, pur non certo della natura indebita della richiesta, accetti di pagare “per sicurezza” o “per evitare problemi”.
La giurisprudenza, però, mostra di richiedere un livello di consapevolezza più netto, non essendo sufficiente una condotta imprudente o colposa.
L’elemento soggettivo resta dunque ancorato al dolo, e in particolare alla coscienza del carattere abusivo e indebito della relazione instaurata con il pubblico agente.
7. Consumazione e tentativo
7.1 La consumazione del reato
L’induzione indebita si caratterizza come reato di evento a struttura bifasica:
– da un lato, la condotta induttiva del pubblico agente,
– dall’altro, la dazione o la promessa indebita da parte del privato.
Secondo Trinci, la consumazione si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene l’adesione del privato, sotto forma di promessa o di dazione.
La giurisprudenza consolidata ritiene che sia sufficiente la promessa, anche orale o implicita, purché seria e credibile.
La dazione, in questo schema, è considerata mero post factum non punibile, in quanto rappresenta soltanto l’attuazione materiale di un accordo già perfezionato sul piano penale.
Così Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 27723: “la promessa indebita integra da sola il delitto di induzione, essendo irrilevante la successiva dazione”.
Altra parte della giurisprudenza, tra cui Pagliaro, ha però sostenuto che, quando alla promessa segua la dazione, vi sia un approfondimento dell’offesa, tale da spostare il momento consumativo all’atto della corresponsione. In questa prospettiva, il reato assumerebbe la forma di “reato progressivo”, in cui ogni dazione successiva rappresenta una nuova fase di realizzazione dell’illecito (Cass. pen., Sez. VI, 28 giugno 2013, n. 28431).
La dottrina maggioritaria tende a valorizzare la promessa come evento sufficiente, riconoscendo però che, nei casi di pluralità di corresponsioni rateali, l’offesa si rinnova e si approfondisce con ogni nuova dazione.
In questo senso, l’illecito può assumere la fisionomia di reato a consumazione frazionata, dove ogni atto di adempimento costituisce segmento ulteriore della lesione.
7.2 L’evento promesso o dato
L’evento consiste nella dazione o promessa di denaro o altra utilità indebita. Come già visto, l’indebitezza deve essere percepita dal privato: se questi ritiene in buona fede che l’utilità sia dovuta, manca il dolo.
La Cassazione ha chiarito che “non è configurabile il reato se la prestazione è resa al fine di adempiere a un obbligo giuridico effettivo, anche se strumentalizzato dal pubblico agente” (Cass. pen., Sez. VI, 26 luglio 2011, n. 31341).
7.3 Il tentativo
Essendo un reato di evento, l’induzione indebita ammette la forma tentata.
Il tentativo si ha quando il pubblico agente pone in essere condotte di pressione, persuasione o suggestione, idonee e dirette in modo non equivoco a determinare il privato alla dazione o promessa, ma l’evento non si verifica.
Un esempio paradigmatico è rappresentato da Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2015, n. 46071: la Corte ha qualificato come tentativo il caso in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere l’utilità richiesta, aveva registrato i colloqui e denunciato i fatti, neutralizzando così l’effetto induttivo.
La giurisprudenza ha chiarito che vi è tentativo anche quando il privato finga di aderire alla pretesa, senza vera volontà di adempiere.
In Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 37509, è stato ritenuto tentativo il caso di promessa meramente simulata, effettuata con il solo scopo di guadagnare tempo o di agevolare l’intervento delle autorità.
È importante sottolineare che l’induzione indebita non è reato bilaterale: le condotte di intraneus ed extraneus si perfezionano autonomamente.
Se l’intraneus agisce ma il privato resiste e non promette o dà, si configura tentativo per il pubblico agente, mentre nessuna responsabilità ricade sull’extraneus.
Lo ha affermato Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 6846, osservando che “il reato si perfeziona in forma tentata quando l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato”.
7.4 Consumazione plurima e continuazione
Quando la dazione avvenga in forma rateale, la giurisprudenza tende a configurare un unico reato, consumato al momento della promessa, ma con effetti che si protraggono e si rinnovano ad ogni corresponsione.
In casi più gravi, si è parlato di continuazione interna, qualora le corresponsioni abbiano carattere autonomo e non si pongano come mero adempimento di un’unica promessa originaria.
8. Rapporti con altri reati
L’art. 319-quater c.p. si apre con una clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che impone di verificare i confini della fattispecie rispetto ad altre figure contigue.
Come osserva Trinci, la norma è nata proprio per colmare un’area di incertezza – la cosiddetta “zona grigia” tra concussione e corruzione – e non può essere compresa se non in relazione dialettica con tali fattispecie.
Induzione indebita e concussione (art. 317 c.p.)
Dopo la riforma del 2012, la giurisprudenza di legittimità ha dato vita a tre distinti orientamenti:
Criterio delle modalità: costrizione = minaccia, induzione = persuasione o suggestione (Cass. pen., Sez. VI, 20 febbraio 2013, n. 8695).
Criterio dell’ingiustizia del danno: concussione se viene prospettato un male ingiusto, induzione se viene evocata conseguenza sfavorevole conforme alla legge (Cass. pen., Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 3251).
Criterio dell’effetto psichico: concussione se vi è annullamento della libertà di autodeterminazione, induzione se permane un margine di scelta (Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 11794).
Con la sentenza Maldera la Corte ha preso le distanze da questi criteri, ritenuti insufficienti, e ha individuato un discrimen più netto:– concussione = minaccia di un male ingiusto, con vittima costretta ad agire per evitare un danno;– induzione indebita = pressione non minacciosa, che altera il processo volitivo ma lascia un margine di scelta al privato, il quale agisce per conseguire un indebito vantaggio.
Come evidenzia Trinci, ne deriva che la concussione resta reato plurioffensivo (tutela PA e vittima), mentre l’induzione indebita è mono-offensiva (tutela esclusiva della PA), con responsabilità anche del privato.
La Corte ha riconosciuto che in casi complessi – minaccia-offerta, minaccia di uso del potere discrezionale, “primario” che chiede denaro per un intervento urgente – il discrimen è difficile. In questi scenari il giudice deve valutare quale fattore (danno ingiusto vs vantaggio indebito) abbia realmente motivato la condotta del privato.
Induzione indebita e corruzione (artt. 318–319 c.p.)
L’induzione indebita si distingue dalla corruzione per la soggezione psicologica dell’extraneus.– Nella corruzione il rapporto è paritario: le parti stipulano un “patto corruttivo” su base negoziale.– Nell’induzione indebita, invece, è l’abuso della funzione pubblica che genera asimmetria e spinge il privato a promettere l’utilità, pur conservando libertà di scelta.
Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2015, n. 50065 ha ribadito che “l’induzione indebita si colloca nell’orbita della corruzione, ma se ne distingue per la presenza di una pressione indebita del funzionario, che altera la parità negoziale”.
Induzione indebita e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La linea di confine individuata da Trinci è sottile:
– Istigazione: il pubblico ufficiale si limita a sollecitare un accordo corruttivo, senza porre il privato in soggezione;
– Induzione: la richiesta assume carattere perentorio, insistente, ultimativo, creando una pressione psicologica.
Cass. pen., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 3750 ha precisato che “l’istigazione implica una proposta paritaria di scambio, l’induzione un abuso che altera il rapporto e condiziona la libertà decisionale dell’extraneus”.
Induzione indebita e millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
– Nel millantato credito, il soggetto si presenta come intermediario, vantando relazioni inesistenti con pubblici ufficiali: manca il contatto diretto con l’intraneus.
– Nel traffico di influenze illecite, il mediatore offre di sfruttare relazioni effettive con il funzionario.
In entrambi i casi, il reato è distinto dall’induzione indebita, dove è lo stesso pubblico ufficiale a esercitare l’abuso.
Induzione indebita e truffa aggravata (art. 640 c.p.)
La linea di confine è particolarmente delicata quando il pubblico agente utilizzi l’inganno.
– Se il privato crede in buona fede che la prestazione sia dovuta, è vittima e il reato è truffa aggravata dall’art. 61, n. 9 c.p.;
– se invece è consapevole dell’indebito ma cede per conseguire un vantaggio, si configura l’induzione indebita.
Induzione indebita e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
La Cassazione ha riconosciuto che, in casi di prestazioni sessuali ottenute abusando della funzione, può configurarsi concorso con la violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 9442).
Tuttavia, pronunce più recenti (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 6741) hanno escluso il concorso, ritenendo che l’induzione indebita sia incompatibile con la lesione della libertà sessuale, da tutelarsi con la più grave fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p.
Secondo la ricostruzione di Trinci, la dottrina si divide:
– per alcuni (Romano), nei casi di rapporti sessuali “negoziati” in cambio di vantaggi indebiti, ricorre l’art. 319-quater;
– per altri (Pelissero), prevale il criterio di consunzione: il reato assorbente è la violenza sessuale, più grave.
Il delitto di induzione indebita si colloca in un terreno di confine:
– rispetto alla concussione, segna il passaggio da vittima a correo del privato;
– rispetto alla corruzione, introduce un elemento di soggezione psicologica che altera la parità negoziale;
– rispetto all’istigazione, richiede un quid pluris di pressione;
– rispetto a millantato credito e traffico di influenze, si caratterizza per la presenza diretta del pubblico ufficiale;
– rispetto alla truffa, presuppone la consapevolezza dell’indebito da parte del privato.
La scelta del legislatore, in linea con le raccomandazioni internazionali, ha così costruito un reato-ponte, capace di punire le aree “grigie” del mercimonio dei pubblici poteri.
10. Profili processuali e sanzionatori
10.1 Competenza e procedibilità
Il delitto di cui all’art. 319-quater c.p. è procedibile d’ufficio e rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale, data la gravità della cornice edittale (art. 33-bis c.p.p.).
La competenza funzionale del collegio garantisce una valutazione collegiale dei casi di confine tra induzione indebita, concussione e corruzione, particolarmente complessi sul piano probatorio e interpretativo.
10.2 Misure cautelari personali e reali
Misure cautelari personali
– Per il comma 1 (soggetto pubblico), sono ammesse tutte le misure cautelari personali, inclusa la custodia cautelare in carcere, in ragione della gravità del reato. È consentito l’arresto facoltativo in flagranza e il fermo.
– Per il comma 2 (privato), le misure sono più limitate: non è consentita la custodia in carcere, ma solo le misure coercitive minori. L’arresto è consentito in flagranza solo nella seconda ipotesi aggravata (PIF).
Misure cautelari reali
L’art. 319-quater rientra tra i delitti che consentono il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente (art. 322-ter c.p.). La giurisprudenza include nella nozione di “profitto” non solo il denaro direttamente percepito, ma anche i beni acquistati con tali somme, come ribadito da Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 10280.
10.4 La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
L’art. 25 del d.lgs. 231/2001 annovera l’induzione indebita tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.– Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;– Sanzioni interdittive: ex art. 9 d.lgs. 231/2001, nei casi più gravi (interdizione dall’attività, divieto di contrattare con la PA, esclusione da contributi e agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni e servizi).
L’inclusione dell’art. 319-quater nel catalogo dei reati 231 risponde alla crescente attenzione internazionale verso le pratiche corruttive nelle relazioni pubblico-privato e mira a responsabilizzare gli enti collettivi.
10.5 Confisca e confisca allargata
Ai sensi dell’art. 322-ter c.p., si applica la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, salvo che appartenga a persona estranea, anche nella forma per equivalente.
L’art. 240-bis c.p. consente di estendere la confisca ai beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, se il condannato non ne giustifica la provenienza.
La ratio risiede nella particolare pericolosità delle condotte corruttive, che tendono a infiltrare in modo occulto la sfera patrimoniale del reo.
L’art. 322-ter.1 c.p. prevede la possibilità di affidare in custodia giudiziale alla polizia giudiziaria i beni sequestrati diversi dal denaro, quando vi sia utilità per esigenze operative.
10.6 Patteggiamento e restituzione integrale
Con la l. 69/2015, è stato introdotto un limite specifico al patteggiamento (art. 444, comma 1-ter c.p.p.):il giudice può ammettere l’applicazione della pena su richiesta delle parti solo se l’imputato provvede alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Questa condizione mira a evitare che il patteggiamento si trasformi in un indebito “sconto di pena” in presenza di arricchimento illecito non neutralizzato.
10.7 Interdizione dai pubblici uffici
Sebbene l’art. 317-bis c.p. non menzioni espressamente l’art. 319-quater, la Cassazione ha chiarito che l’induzione indebita comporta comunque l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, trattandosi di delitto commesso con abuso di poteri.
La durata è determinata secondo i criteri degli artt. 29, 31 e 37 c.p. (Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228).
Fonti: Alessandro Trinci, commento all'art. 319 quater c.p. Amato, Concussione: resta solo la condotta di «costrizione», in Giur. dir. 2012, n. 48; Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, II, Milano, 1999; Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013; Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze «improcrastinabili» di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999; Pagliaro, Principi di Diritto Penale - Parte speciale, I, Milano, 2000; Pelissero, Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. I delitti di corruzione, Milano, 2015; Ravagnan, La concussione, in D'Avirro (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Padova, 1999; Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013. Gatta, Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto sulla situazione, in attesa dell’imminente approvazione definitiva, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2018; Spena, Per una critica dell'art. 319-quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?, in penalecontemporaneo.it. V. anche sub art. 317.F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Milano, varie edizioni.
G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Zanichelli, ult. ed.
F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, Cedam, ult. ed.
L. Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999.
E. Dolcini – C.E. Paliero (a cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, ult. ed. (art. 317–319-quater).