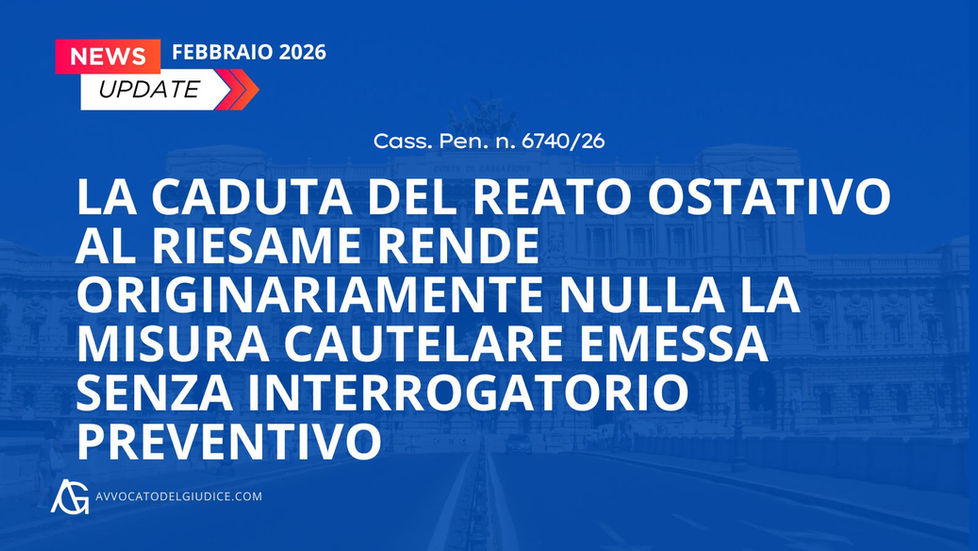Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 c.p.
- 14 apr 2025
- Tempo di lettura: 8 min

Indice:
Premessa storica: le origini del peculato nel diritto romano
Il peculato affonda le sue radici nel diritto penale romano, dove inizialmente designava il delitto di appropriazione di bestiame pubblico (peculatus), collegato alla pecunia come forma primitiva di ricchezza mobile.
Solo in epoca successiva, il concetto venne esteso al denaro e ai beni appartenenti alla res publica.
La lex Iulia peculatus, di epoca cesariana o augustea, disciplinava espressamente tale fattispecie, accorpandola a quella del sacrilegium, con cui condivideva l'offensività nei confronti della sfera pubblica e del patrimonio collettivo.
La repressione del peculato, in quanto crimen publicum, era affidata a una specifica quaestio perpetua, che ne garantiva il giudizio.
Le sanzioni conosciute nell'età repubblicana erano principalmente di natura pecuniaria, spesso corrispondenti al quadruplo del valore sottratto.
Tuttavia, nel diritto imperiale e soprattutto giustinianeo, il reato fu inasprito con pene corporali e capitali, tra cui la deportazione e la morte, riflettendo la crescente sacralizzazione dell'erario e del fisco come strumenti essenziali del potere statale.
L'evoluzione codicistica in Italia: dal codice Zanardelli al codice Rocco
Nel codice penale del 1889 (art. 168), il peculato era delineato come la condotta del pubblico ufficiale che sottraesse o distraesse danaro o altra cosa mobile della quale aveva la disponibilità in virtù delle funzioni esercitate. In tale contesto normativo, la figura del soggetto attivo era limitata al solo pubblico ufficiale, escludendosi l'incaricato di pubblico servizio, e si dibatteva se il reato potesse configurarsi anche nel caso di appropriazione di beni appartenenti a privati ma affidati all'agente per ragioni d'ufficio.
Con l'entrata in vigore del codice Rocco nel 1930, il legislatore operò una sistematizzazione più rigorosa e articolata della materia, prevedendo tre distinte ipotesi criminose: il peculato propriamente detto (art. 314 c.p.), che punisce l'appropriazione di beni pubblici da parte di soggetti qualificati; la malversazione a danno dei privati (art. 315 c.p.), per i casi di appropriazione di beni di privati in possesso del pubblico agente per ragioni di servizio; e infine il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), ipotesi residuale ma significativa, volta a colpire la ritenzione indebita di utilità ricevute in modo erroneo.
La riforma del 1990 (l. 86/1990) ha segnato una svolta rilevante introducendo, al secondo comma dell'art. 314, la figura del "peculato d'uso", volta a sanzionare appropriazioni momentanee con immediata restituzione, al fine di distinguere le condotte meramente strumentali dalle vere e proprie forme di spoliazione dell'erario.
Da ultimo, la riforma Nordio (l. n. 137/2023) ha reintrodotto, con l'art. 314-bis c.p., la figura del peculato per distrazione, espunta dalla formulazione originaria dell'art. 314 con la riforma del 1990, colmando un vuoto normativo emerso nella prassi amministrativa e giurisprudenziale. Il nuovo articolo consente di perseguire le condotte di destinazione indebita di denaro o beni mobili pubblici a fini diversi da quelli istituzionali, anche in assenza di appropriazione definitiva, ampliando così la tutela penale del patrimonio pubblico in chiave preventiva e funzionale.
Tipo di peculato | Norma di riferimento | Condotta tipica | Pena prevista |
Peculato ordinario | Art. 314, co. 1 c.p. | Appropriazione indebita di bene pubblico | Reclusione da 3 a 10 anni |
Peculato d'uso | Art. 314, co. 2 c.p. | Uso momentaneo con immediata restituzione | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Peculato mediante errore altrui | Art. 316 c.p. | Ritenzione indebita a seguito di errore | Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa |
Peculato per indebita destinazione | Art. 314-bis c.p. | Destinazione di beni pubblici a fini diversi | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Struttura della fattispecie di peculato (art. 314 c.p.)
Il reato di peculato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio la disponibilità o il possesso di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Il possesso, qui, è qualificato: non si tratta di un possesso in senso civilistico, derivante da un contratto o da un rapporto tra privati, bensì di un possesso strumentale e fiduciario, funzionalmente connesso all’esercizio della funzione pubblica.
L’agente, in tale ipotesi, non detiene il bene con titolo pieno, ma in quanto investito di un ruolo istituzionale che gli impone di amministrarlo nell’interesse dell’ente di appartenenza.
È proprio la violazione di tale vincolo fiduciario che segna il disvalore penale della condotta.
La giurisprudenza, in continuità con l’elaborazione dottrinale, definisce l'appropriazione come interversio possessionis: un mutamento del titolo di detenzione che manifesta l’intenzione dell’agente di comportarsi uti dominus, cioè come se fosse proprietario, disconnettendo il bene dalla sua destinazione pubblica e appropriandosene in senso materiale e giuridico.
Tale condotta può concretizzarsi in molteplici modalità: dalla mera omissione della restituzione, all’occultamento, fino alla negoziazione a favore di terzi.
Accanto all'appropriazione, la norma, nella sua formulazione originaria, contemplava anche la distrazione del bene, ossia l'utilizzo per fini diversi da quelli istituzionali.
Questa ipotesi fu espunta con la riforma del 1990, per evitare una punibilità eccessivamente ampia, ma è stata reintrodotta dalla legge n. 137/2023 con l’introduzione dell’art. 314-bis c.p., rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili".
Tale disposizione ha l’obiettivo di colmare il vuoto normativo venutosi a creare, sanzionando quelle condotte elusive che, pur non realizzando un’appropriazione in senso stretto, deviano i beni pubblici dalla loro destinazione funzionale, compromettendo l’efficienza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Soggetto attivo | Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio |
Oggetto materiale | Denaro o cosa mobile appartenente alla PA, di cui il soggetto ha possesso |
Condotta | Appropriazione con interversio possessionis |
Dolo | Generico: volontà consapevole di comportarsi come proprietario |
Momento consumativo | Istante dell'interversio possessionis |
Elemento soggettivo e momento consumativo
L'elemento soggettivo del peculato è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla volontà cosciente e consapevole dell'agente di appropriarsi del bene mobile o del denaro altrui, nella piena consapevolezza della sua appartenenza alla pubblica amministrazione.
Non è dunque richiesta la finalità di profitto o l'animus lucrandi, ma semplicemente la consapevole volontà di comportarsi come titolare del bene, ponendolo fuori dalla sfera giuridica dell'ente.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'elemento soggettivo implica anche la rappresentazione della funzione pubblica rivestita dall’agente e del vincolo fiduciario che essa comporta.
L’ignoranza incolpevole dell’altruità del bene o l’errore su un presupposto di fatto (ad esempio, una confusione tra oggetti simili o la convinzione erronea di essere autorizzati) possono escludere il dolo, in quanto impediscono la cosciente volontà di sottrazione.
Quanto al momento consumativo, il reato di peculato si consuma nel preciso istante in cui si verifica l'interversio possessionis, ovvero quando l'agente compie un atto che manifesta in modo inequivoco la volontà di trattare il bene come proprio, disconnettendo il nesso funzionale tra bene e pubblica amministrazione. Tale atto deve essere esteriore, concretamente apprezzabile e sintomatico della volontà di appropriazione.
La Suprema Corte ha ribadito in numerose pronunce (tra cui Cass., sez. VI, n. 24946/2019) che integra il reato anche il ritardo volontario, significativo e non giustificato nella restituzione del bene, a condizione che risulti accompagnato da un animus sibi habendi, ossia dalla volontà di far proprio il bene per un periodo di tempo sufficiente a realizzare la sottrazione rispetto alla destinazione istituzionale. Non rileva, ai fini dell’integrazione del reato, che la restituzione sia successivamente avvenuta, trattandosi di condotta già perfezionata nel momento dell’appropriazione.
Peculato d'uso (art. 314, co. 2 c.p.)
Il secondo comma dell'art. 314 introduce una forma attenuata di peculato, denominata "peculato d'uso", che si verifica quando il colpevole abbia agito esclusivamente allo scopo di fare un uso momentaneo del bene e lo abbia poi restituito immediatamente.
Tale figura si distingue dal peculato ordinario per l'assenza dell'animus rem sibi habendi, cioè della volontà di acquisire stabilmente il bene, e per la restituzione tempestiva del medesimo, idonea a escludere la definitiva interversio possessionis.
La pena è notevolmente più mite: reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Affinché si configuri il peculato d'uso, è necessario che l'utilizzo sia effettivamente temporaneo, sia nella volontà soggettiva dell'agente che nella sua concreta attuazione, e che non si determini un pregiudizio sostanziale alla funzionalità dell'amministrazione pubblica (Cass. Pen., sez. VI, n. 1862/1992). Il bene deve essere impiegato per fini estranei al servizio, ma in modo tale da non comprometterne definitivamente la disponibilità o l'integrità.
La giurisprudenza ha escluso la configurabilità del peculato d'uso nei casi in cui l'utilizzo risulti prolungato, strumentale a fini personali e caratterizzato da alterazioni fisiche del bene o da mancanza di spontaneità nella restituzione. Emblematico è il caso dell'utilizzo domestico di componenti informatici dell'ufficio (hard disk, lettori DVD, RAM), successivamente rimontati solo dopo la scoperta del fatto: tale condotta è stata qualificata come peculato ordinario in quanto espressiva di una volontà appropriativa e di un uso prolungato incompatibile con la natura temporanea richiesta per l'applicazione del secondo comma (Cass. Pen., sez. VI, n. 25534/2014).
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
Questa particolare forma di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, riceve o trattiene indebitamente denaro o altra utilità, approfittando dell'errore altrui, che può provenire sia da un privato sia da un altro pubblico agente.
L'errore, in tal caso, deve essere causalmente rilevante, ovvero determinante ai fini della indebita attribuzione patrimoniale.
La condotta non richiede attività attiva o fraudolenta da parte del soggetto agente, ma si basa su una mera passività dolosa, cioè sulla consapevole volontà di trarre vantaggio da un errore senza operare alcuna correzione.
La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa fino a 10.000 euro.
La norma colma uno spazio grigio tra l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), dove il possesso iniziale è legittimo ma la successiva appropriazione è abusiva, e la concussione (art. 317 c.p.), che implica una costrizione o induzione indebita da parte del pubblico agente.
Nel peculato per profitto dell'errore altrui manca qualsiasi forma di pressione psicologica o minaccia, ma vi è comunque una violazione del dovere di lealtà e correttezza che grava sul pubblico funzionario.
L'indebita ritenzione di quanto non dovuto, pur in assenza di artifizi o violenze, costituisce comunque una lesione al buon andamento e alla legalità dell'azione amministrativa.
Secondo la giurisprudenza, rileva anche il semplice silenzio serbato dal pubblico agente che, pur consapevole dell’errore, ometta di segnalare l’anomalia e trattenga quanto ricevuto indebitamente (cfr. Cass., sez. VI, n. 24447/2020).
Bene giuridico tutelato
La dottrina prevalente individua nel peculato un reato plurioffensivo, in quanto lesivo di una pluralità di beni giuridici di rilievo costituzionale.
In primo luogo, esso tutela il patrimonio della pubblica amministrazione inteso non solo in termini strettamente economici, ma anche quale espressione dell’interesse collettivo alla corretta gestione delle risorse pubbliche.
In secondo luogo, il reato incide direttamente sui principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), minacciando la trasparenza e l’efficienza dell’azione pubblica.
Sotto un profilo sistematico, il peculato si colloca tra i reati che ledono la fiducia istituzionale e la credibilità della funzione pubblica, poiché rappresenta un tradimento del mandato fiduciario conferito all’agente.
Non a caso, la giurisprudenza costituzionale e ordinaria ha evidenziato come la condotta peculativa comprometta il rapporto fiduciario tra cittadino e istituzione, minando le basi etiche dell’amministrazione e contribuendo all’erosione del senso civico.
In tal senso, il peculato si distingue da altri reati patrimoniali per la particolare gravità del disvalore istituzionale che veicola, ponendosi al crocevia tra criminalità economica e corruzione sistemica.
Sanzioni e conseguenze accessorie
Il peculato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (art. 314, co. 1 c.p.) e comporta l'applicazione obbligatoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, misura accessoria che sottolinea la gravissima lesione arrecata alla funzione pubblica e all'affidamento della collettività nell'integrità della pubblica amministrazione. Tuttavia, nei casi in cui venga irrogata una pena detentiva inferiore a tre anni per effetto del bilanciamento con circostanze attenuanti, l'interdizione è limitata nel tempo, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e ss. c.p.
Tale sanzione accessoria solleva peraltro questioni di legittimità costituzionale, specialmente nei casi di peculato d'uso, in cui la minore gravità della condotta potrebbe rendere sproporzionata l'interdizione perpetua, con conseguente vulnus ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (artt. 3 e 27, co. 3 Cost.).
L'art. 322-ter c.p. prevede inoltre la confisca obbligatoria del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, misura che si affianca alla pena principale con funzione eminentemente ripristinatoria del danno patrimoniale subito dalla pubblica amministrazione.
Tale previsione trova applicazione automatica in presenza di condanna o patteggiamento, e costituisce un potente strumento di contrasto all’arricchimento illecito.
La condanna per peculato comporta altresì l'ineleggibilità a cariche elettive e la sospensione da funzioni pubbliche, in linea con le previsioni dell'art. 11 del D.lgs. 235/2012 (c.d. Legge Severino), con conseguenze rilevanti anche sul piano politico e reputazionale del soggetto condannato.
Misura | Norma | Applicabilità |
Interdizione perpetua | Art. 28 c.p. | Sempre, salvo pena < 3 anni |
Confisca obbligatoria | Art. 322-ter c.p. | Profitto del reato o per equivalente |
Ineleggibilità/sospensione | D.lgs. 235/2012, art. 11 | Condanna definitiva per reati contro la PA |