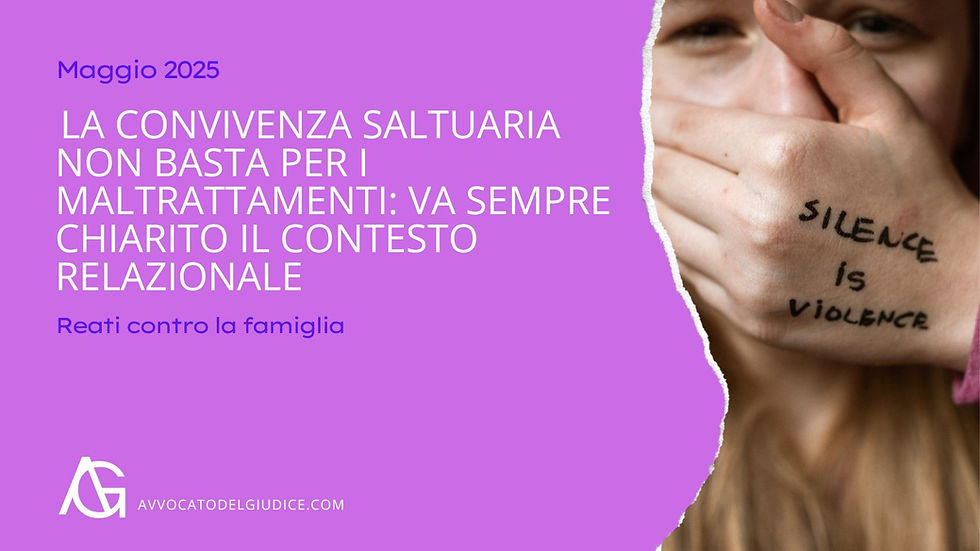Maltrattamenti in famiglia e minori presenti: la Cassazione impone rigore sull’aggravante, non basta un solo episodio (Cass. pen. n. 20128/25)
- 31 mag 2025
- Tempo di lettura: 9 min

1. Premessa
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20128/2025, è intervenuta a chiarire i presupposti applicativi della circostanza aggravante prevista dall’art. 572, comma 2, c.p., nei casi in cui il reato di maltrattamenti in famiglia sia commesso in presenza di un minore.
La Suprema Corte ha annullato con rinvio una condanna che aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’aggravante, la percezione indiretta degli atti da parte del minore.
Per i giudici di legittimità, non basta un singolo episodio né un semplice stato emotivo riferito da terzi: occorre la presenza del minore a una pluralità di condotte, gravi e reiterate, idonee a ledere il suo sviluppo psicofisico.
2. Il caso: condanna per maltrattamenti con aggravante fondata su “terrore” percepito dal minore
L’imputato era stato condannato per maltrattamenti aggravati e lesioni personali nei confronti del fratello, convivente, con applicazione dell’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p., in ragione della presunta presenza di un minore (il figlio della vittima) durante i fatti. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente, a tal fine, la dichiarazione della madre secondo cui il bambino “era spaventato” e “aveva sentito delle frasi violente”.
3. Il nodo interpretativo: cosa significa "fatto commesso in presenza di minore"?
La Corte di cassazione ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’aggravante, rilevando l’esistenza di due orientamenti contrapposti:
secondo una prima linea interpretativa, basta un solo episodio commesso alla presenza del minore, anche in reati abituali come l’art. 572 c.p.;
secondo un indirizzo più restrittivo — cui la Corte ora si conforma — l’aggravante richiede l’assistenza a una pluralità di episodi, gravi e reiterati, che evidenzino la concreta offensività della condotta rispetto allo sviluppo psicologico del minore.
La seconda interpretazione, afferma la Cassazione, è l’unica coerente con:
la ratio teleologica dell’aggravante, volta a proteggere la crescita psico-emotiva del minore;
i principi costituzionali di offensività e proporzionalità (artt. 3, 25, 27 Cost.);
l'esigenza di evitare automatismi punitivi in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
4. Offensività in concreto e funzione della pena
La Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 139/2023, secondo cui ogni sanzione deve misurarsi con l’effettivo disvalore della condotta. Una aggravante che comporta un aumento fino alla metà della pena non può fondarsi su una singola percezione emotiva, magari riferita indirettamente. Il minore deve aver assistito a una serie di episodi significativi, per numero e gravità, tali da giustificare il salto qualitativo di disvalore penale.
5. Conclusione: annullamento con rinvio per nuovo esame del fatto
Alla luce di queste premesse, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando che la motivazione della Corte d’appello non forniva alcuna certezza:
né circa la presenza effettiva del minore durante le condotte;
né circa il numero, la ricorrenza o la gravità degli episodi.
Il nuovo giudizio, affidato a diversa Sezione della Corte d’appello di Milano, dovrà riesaminare se ricorrano, in concreto, i presupposti per l'applicazione dell’aggravante.
Per approfondire il tema va qui.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 22/05/2025, (ud. 22/05/2025, dep. 29/05/2025), n.20128
RILEVATO IN FATTO
1. Pa.Ch. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 572, commi primo e secondo, e 582 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., essendo emerso dall'istruttoria che il minore non era presente alle condotte integranti i maltrattamenti.
Tale aggravante, sostiene il ricorrente, è stata erroneamente ritenuta sul presupposto che il minore avesse, comunque, percepito ciò che accadeva e sulla base di quanto riferito dalla madre, ovvero che il minore era spaventato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Va, innanzitutto, premesso che la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 1, comma 1 -bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11-quinquies dell'art. 61 cod. pen. con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.
La legge 19 luglio 2019, n. 69 (in vigore dal 9 agosto 2019) ha nuovamente introdotto al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma. La norma, infatti, prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. il riferimento all'art. 572 cod. pen., cosicché dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dal secondo comma dell'art. 572.
2.2. Secondo un indirizzo ermeneutico formatosi in relazione all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, Rv. 281051; Sez. 6 , n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274924).
Si è, infatti, distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza si è ritenuto sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in relazione all'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 572, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6,n. 21998 del 05/05/2023, Rv. 285118; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, Rv. 283162).
2.3. Altro indirizzo ermeneutico, discostandosi da tale soluzione, ha, invece, affermato che, ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 31929 del 25/06/2024, Rv. 286867; Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, Rv. 285479).
Muovendo da una interpretazione della fattispecie aggravata quale reato di pericolo astratto, in quanto fondata sull'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica, con riferimento alla soglia minima di condotte rilevante ai fini della configurabilità dei "maltrattamenti assistiti", si è ritenuto necessario, sul piano della offensività in concreto e, dunque, della "tipicità" della condotta, che il minore, qualunque ne sia l'età, sia stato presente ad un numero di episodi che, per la loro gravità (non dovendo peraltro consistere nell'uso della violenza fisica) e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano compromettere il sano sviluppo psico-fisico.
2.3. Il Collegio ritiene di aderire a tale secondo indirizzo ermeneutico, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante in esame, che il minore assista ad una sola condotta.
Come già affermato da Sez. 6, n. 31929 del 25/06/2024, Rv. 286867, tale conclusione trova il proprio fondamento in ragioni di carattere teleologico, testuale e sistematico.
Va, innanzitutto, considerato che la "ratio" dell'aggravante in esame va individuata nell'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti deboli mediante la tutela della loro integrità psicologica e di quella fisica, l'una suscettibile di essere compromessa nel caso in cui il minore sia spettatore di violenza in ambito familiare e l'altra ove egli stesso sia vittima di violenza (cfr. Sez. 3, n. 21024 del 28/04/2022, Rv. 283204). Si è, infatti, osservato che, in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azioni aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati.
Il legislatore, dunque, ha inteso attribuire un maggiore disvalore penale ai fatti commessi in presenza o in danno di minori (oltre che delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 572 cod. pen.) e ciò in ragione dell'amplificazione del raggio di offensività della condotta di maltrattamenti, estesa, oltre che al soggetto maltrattato, anche a colui che assiste a siffatte condotte maltrattanti.
Va, inoltre, considerato che da un punto di vista testuale, la norma richiede che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, "il fatto" sia commesso in presenza o in danno di una persona minore.
In assenza di ulteriori specifiche indicazioni normative, la questione interpretativa che si pone attiene proprio all'individuazione del significato da attribuire a tale lemma, se in relazione ad una o più condotte.
Ad avviso del Collegio, il termine "fatto" deve essere necessariamente interpretato in correlazione con la ratio dell'aggravante e con la struttura abituale del reato cui accede. Va, infatti, considerato che la condotta criminosa idonea ad integrare il reato in esame può manifestarsi attraverso fatti sia commissivi che omissivi - quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ovvero, ancora, atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità - che, isolatamente considerati, possono anche essere privi di rilevanza penale (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, Rv. 267270), rilevanza che, tuttavia, acquistano per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità (Sez. 6, n. 34480 del 31/05/2012, Rv. 253568).
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'aggravante e della struttura necessariamente abituale del reato cui accede, deve ritenersi che il "fatto" cui assiste il minore deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.
Tale soluzione appare coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità.
Va, in primo luogo, rammentato l'insegnamento della Corte costituzionale in tema di necessaria offensività del reato. In particolare, da ultimo, Corte cost. n. 139 del 2023, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha chiarito che tale principio - la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'insieme dei valori connessi alla dignità umana - opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività "in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto").
Strettamente correlato a tale valutazione di offensività in concreto della condotta è il principio di proporzionalità della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., che, come recentemente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 217 del 2023), esige che la pena sia adeguatamente calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al suo disvalore soggettivo.
Ebbene, ad avviso del Collegio, una interpretazione della fattispecie aggravata di "maltrattamenti assistiti" coerente con i principi sopra richiamati non può prescindere dalla valutazione della concreta offensività della condotta tipica e, dunque, dall'accertamento della presenza del minore ad un numero di episodi che per la loro gravità, intensità e reiterazione nel tempo, sia idoneo a trasporre nella fattispecie concreta la valutazione di astratta offensività formulata dal legislatore sulla base dell'id quod plerumque accidit.
Di contro, l'adesione all'orientamento ermeneutico qui disatteso potrebbe comportare una possibile frizione con i suddetti principi di offensività e proporzionalità della pena nonché, in ultima analisi, con la funzione rieducativa della pena. La circostanza aggravante in esame, proprio in ragione della maggiore offensività del fatto, da valutare, come detto, nella sua globalità e non con riferimento ai singoli episodi, comporta un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio con l'aumento fino alla metà della pena. Ove si ritenesse sufficiente la realizzazione di un singolo episodio alla presenza o in danno di un minore (o delle altre persone contemplate dalla norma in esame), il notevole incremento sanzionatorio correlato all'aggravante potrebbe fondatamente far percepire tale pena come ingiusta, compromettendone, cosi, la funzione rieducativa ad essa costituzionalmente assegnata.
3. Venendo all'esame del ricorso, come rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la motivazione della sentenza impugnata in merito alla configurabilità dell'aggravante in esame appare carente, in quanto, oltre ad aderire all'indirizzo ermeneutico qui disatteso, dalla stessa non emerge con certezza né se il minore è mai stato presente ad alcuna condotta maltrattante tenuta dal fratello né il numero degli episodi cui avrebbe assistito.
La Corte territoriale, infatti, si è limitata a valorizzare la sola circostanza riferita dalla madre dell'imputato ovvero che il figlio minore era "terrorizzato" e che aveva sentito delle frasi pronunciate dal fratello. A fronte di tale scarna motivazione, inidonea a evidenziare gli elementi strutturali dell'aggravante (presenza del minore a più episodi di maltrattamento che per qualità e intensità siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico) si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
di appello di Milano.
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2025.